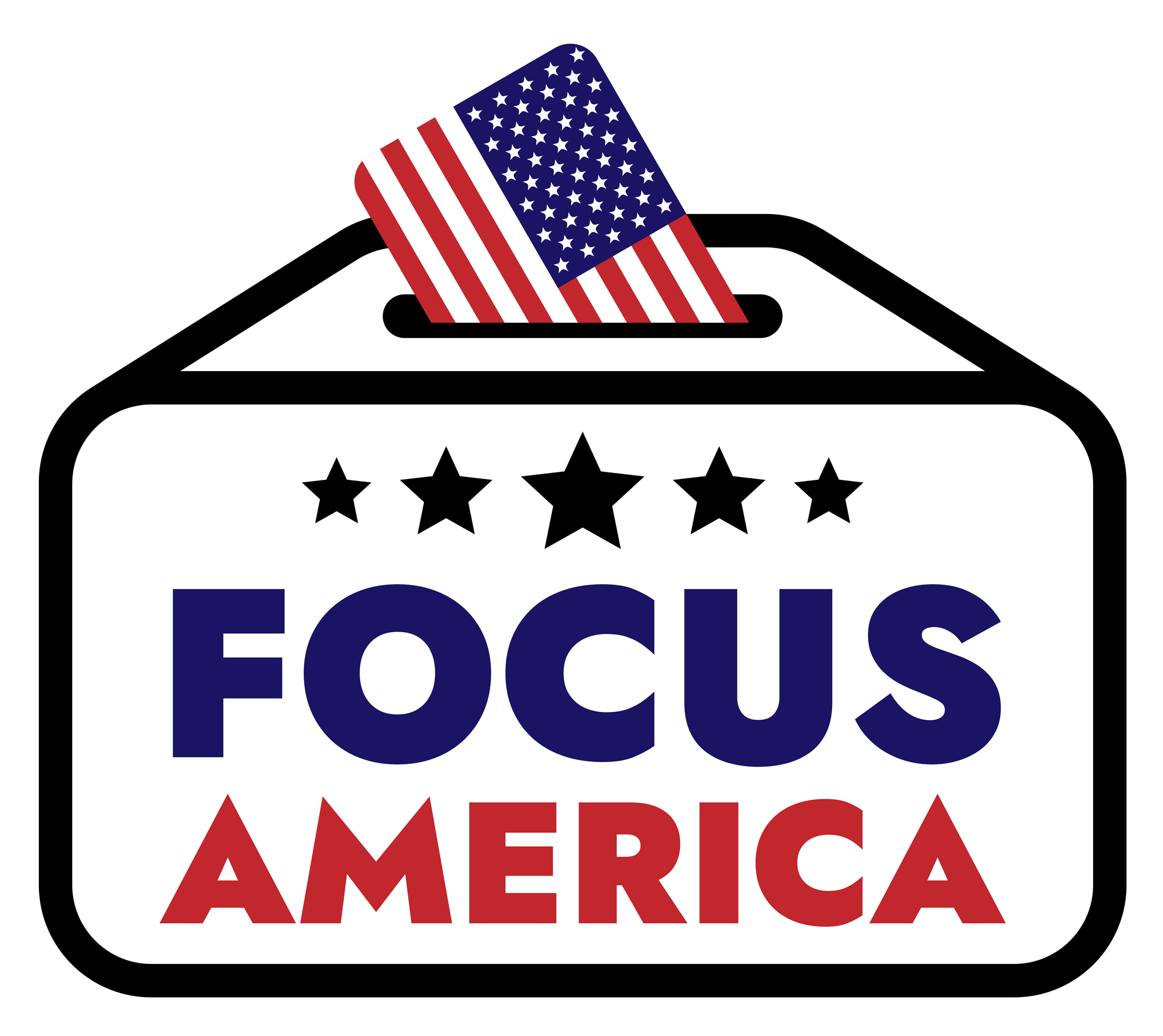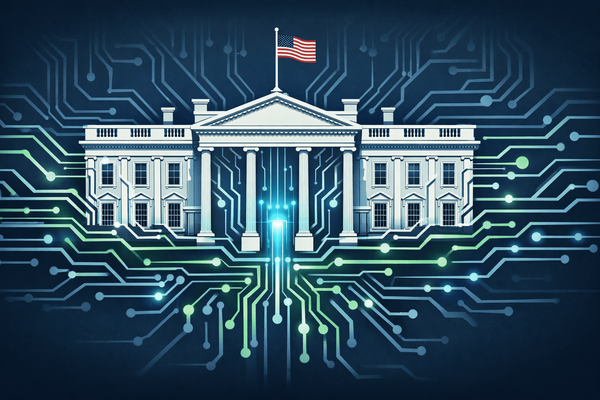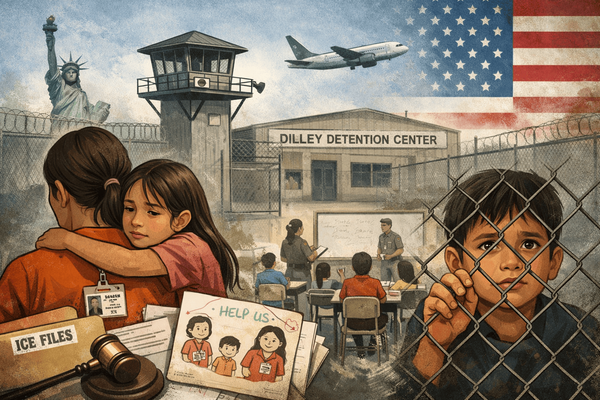Perché la reindustrializzazione resta un miraggio
Con l’imposizione di dazi fino al 50% su importazioni da 80 Paesi, gli Stati Uniti guidano un’ondata protezionista che sta ridisegnando la geografia degli scambi. Ma la promessa di riportare le fabbriche sul suolo americano si scontra con la realtà

I dazi imposti dal presidente Donald Trump stanno cambiando radicalmente il commercio mondiale. A partire dal 7 agosto, gli Stati Uniti introdurranno tariffe “reciproche” di almeno il 10% sulle esportazioni di circa 80 Paesi, con picchi fino al 50%. L’entrata in vigore, inizialmente fissata per il 1° agosto, è stata rinviata per permettere all’amministrazione doganale di prepararsi. In questa nuova fase protezionista, la prima economia mondiale alza un muro di tasse come non si vedeva dagli anni ’30 del Novecento, con una media dei dazi che passerà dal 2,5% a circa il 17%.
Trump ha ottenuto una vittoria simbolica con l’Unione europea, che il 27 luglio ha accettato dazi del 15% senza adottare contromisure. Nei giorni seguenti sono arrivati annunci simili dalla Corea del Sud (15%), dalle Filippine e dalla Thailandia (entrambe al 19%). Tuttavia, questi accordi restano cornici negoziali senza valore giuridico vincolante.
L’obiettivo dichiarato della Casa Bianca è duplice: da un lato, spingere i partner commerciali a investire negli Stati Uniti; dall’altro, ridurre la dipendenza da importazioni straniere, soprattutto cinesi. Trump ha definito la misura “una politica che rende gli Stati Uniti grandi e ricchi di nuovo”.
Ma la strategia comporta conseguenze geopolitiche e strutturali rilevanti. Gli Stati Uniti esentano gran parte delle importazioni da Canada e Messico, considerate essenziali per l’esistenza di una “fabbrica nordamericana”. La Cina è invece il principale bersaglio della nuova dottrina economica americana. Per il resto del mondo, Washington applica un protezionismo uniforme, minacciando ritorsioni verso chi tenta contromisure.
Questa impostazione rompe con il principio di non discriminazione commerciale, cardine dell’Organizzazione mondiale del commercio. Dal 1980 a oggi, il valore degli scambi globali è quintuplicato grazie all’apertura dei mercati. Il nuovo corso statunitense segna una rottura storica.
Gli effetti si fanno già sentire. Il diritto doganale diventa per molte aziende un’imposta aggiuntiva più rilevante della stessa IVA. In settori come acciaio e auto, è ormai la voce fiscale principale. Le imprese multinazionali risultano avvantaggiate, potendo redistribuire la produzione grazie a una presenza globale. Le piccole e medie imprese, invece, rischiano di non reggere l’urto.
L’Unione europea, con il suo mercato da 450 milioni di consumatori, non basta più a bilanciare la pressione americana. Alcuni Stati membri, soprattutto dell’Europa centrale, hanno accettato le richieste statunitensi per timore di perdere la protezione militare americana. Il legame tra scambi commerciali e garanzie di sicurezza indebolisce l’UE, che fatica a rispondere come attore unificato. Bruxelles punta ora su accordi commerciali “di nuova generazione” e sulla tassa sul carbonio alle frontiere per esportare i propri standard ambientali e sociali. Ma la credibilità europea rischia di uscire danneggiata, soprattutto nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.
Il reindirizzamento degli investimenti è già visibile. L’accordo con l’UE prevede, almeno nominalmente, 600 miliardi di dollari di nuovi investimenti negli Stati Uniti. Il Giappone ha promesso 550 miliardi. Il colosso del lusso LVMH aprirà un nuovo sito produttivo negli USA, mentre AstraZeneca costruirà una fabbrica in Virginia per 50 miliardi di dollari. Sul sito della Casa Bianca, nella sezione “Effetto Trump”, si leggono altre cifre: 23 miliardi da Novartis, 20 da CMA CGM.
Tuttavia, l’impatto sull’occupazione è incerto. L’industria americana rappresenta oggi solo l’8% della forza lavoro, contro il 22% nel 1979. Secondo Bank of America, “queste nuove linee di produzione saranno in gran parte automatizzate” e non creeranno grandi volumi di occupazione. A ciò si aggiunge la fine, decisa da Trump il 7 luglio, del piano di incentivi fiscali varato da Joe Biden per sostenere l’industria green. Da quel momento, gli investimenti manifatturieri si sono fermati.
Il primo trimestre del 2025 ha registrato un calo degli investimenti esteri a 52,8 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2022. Allo stesso tempo, resta fortissima la carenza di manodopera: 400.000 posti nell’industria sono vacanti. Il problema è aggravato dalle espulsioni di massa: in sei mesi, l’Immigration and Customs Enforcement ha effettuato circa 100.000 arresti. Il restringimento del bacino lavorativo potrebbe spingere ulteriormente al rialzo i salari.
Infine, va considerato l’effetto boomerang. Le barriere doganali possono tutelare alcuni settori, ma danneggiano altri. Studi condotti da ricercatori dell’università di Harvard e della California hanno mostrato che i dazi sull’acciaio introdotti nel 2018 crearono 1.000 posti di lavoro, ma ne distrussero 75.000 altrove, per via dell’aumento dei costi.
Nel frattempo, mentre gli Stati Uniti si ripiegano, altre economie cercano di rafforzare i legami commerciali. L’India ha rilanciato negoziati con l’UE e la Nuova Zelanda. L’accordo transpacifico (CPTPP) apre a nuovi partner nel Sud-Est asiatico. Si delinea un’economia globale più regionalizzata, con alleanze fra Paesi affini per prossimità geografica e strategica.
Il ritorno del protezionismo sembra quindi una tendenza strutturale. Ma, al di là della retorica, la promessa di Trump di riportare la manifattura negli Stati Uniti si scontra con ostacoli materiali: automazione, carenza di lavoratori, concorrenza internazionale. E soprattutto con una realtà economica che, anche sotto dazi, resta interdipendente.