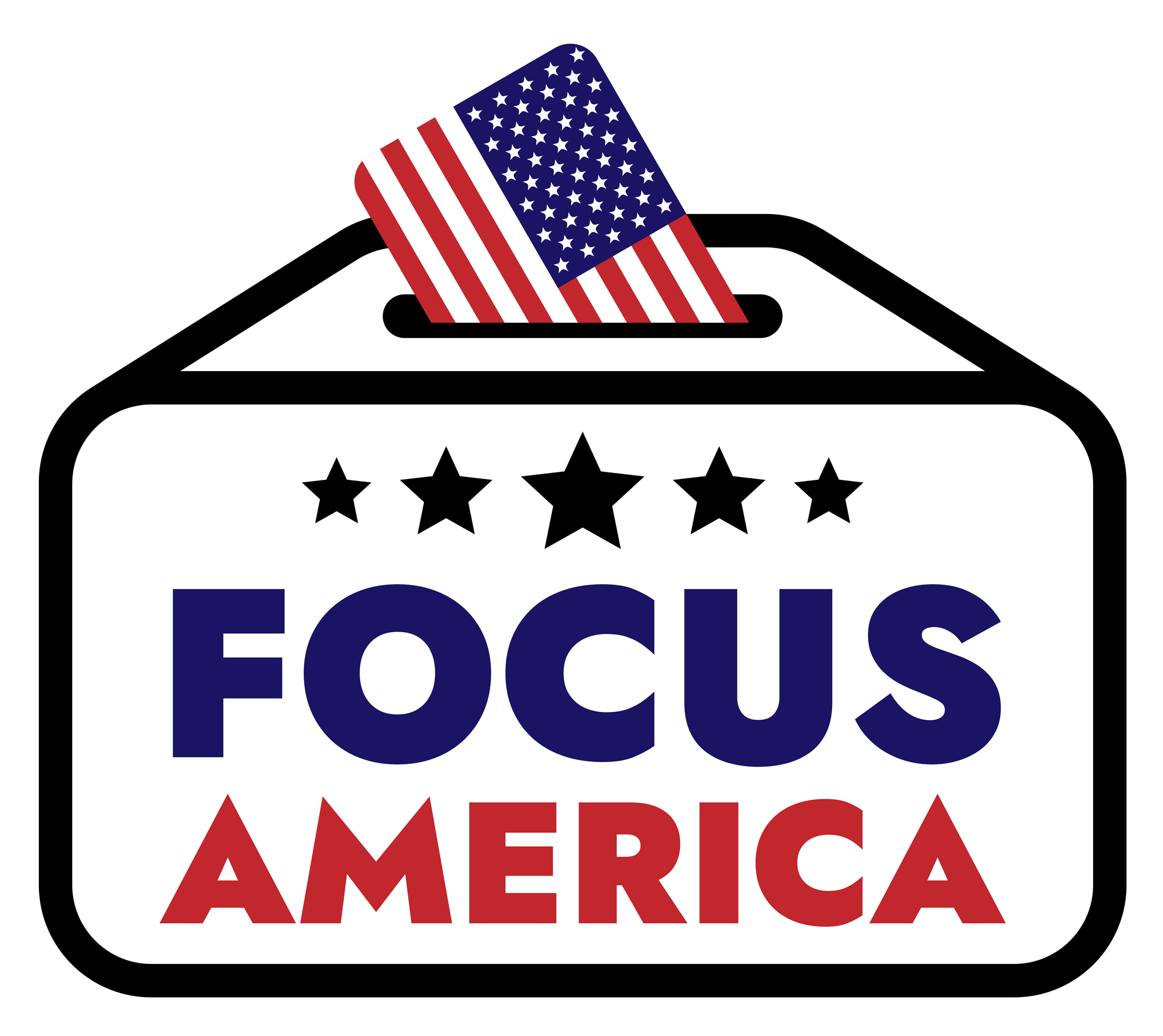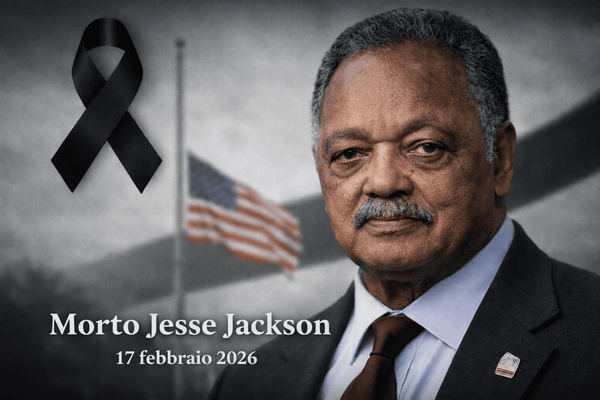I primi 100 giorni di Trump: i dazi mettono in crisi gli Stati Uniti?
Nei primi 100 giorni del secondo mandato, Trump ha introdotto dazi universali sulle importazioni, innescando turbolenze finanziarie e rischi di recessione. La sua strategia mira a isolare la Cina, ma espone l’economia americana a nuove fragilità.
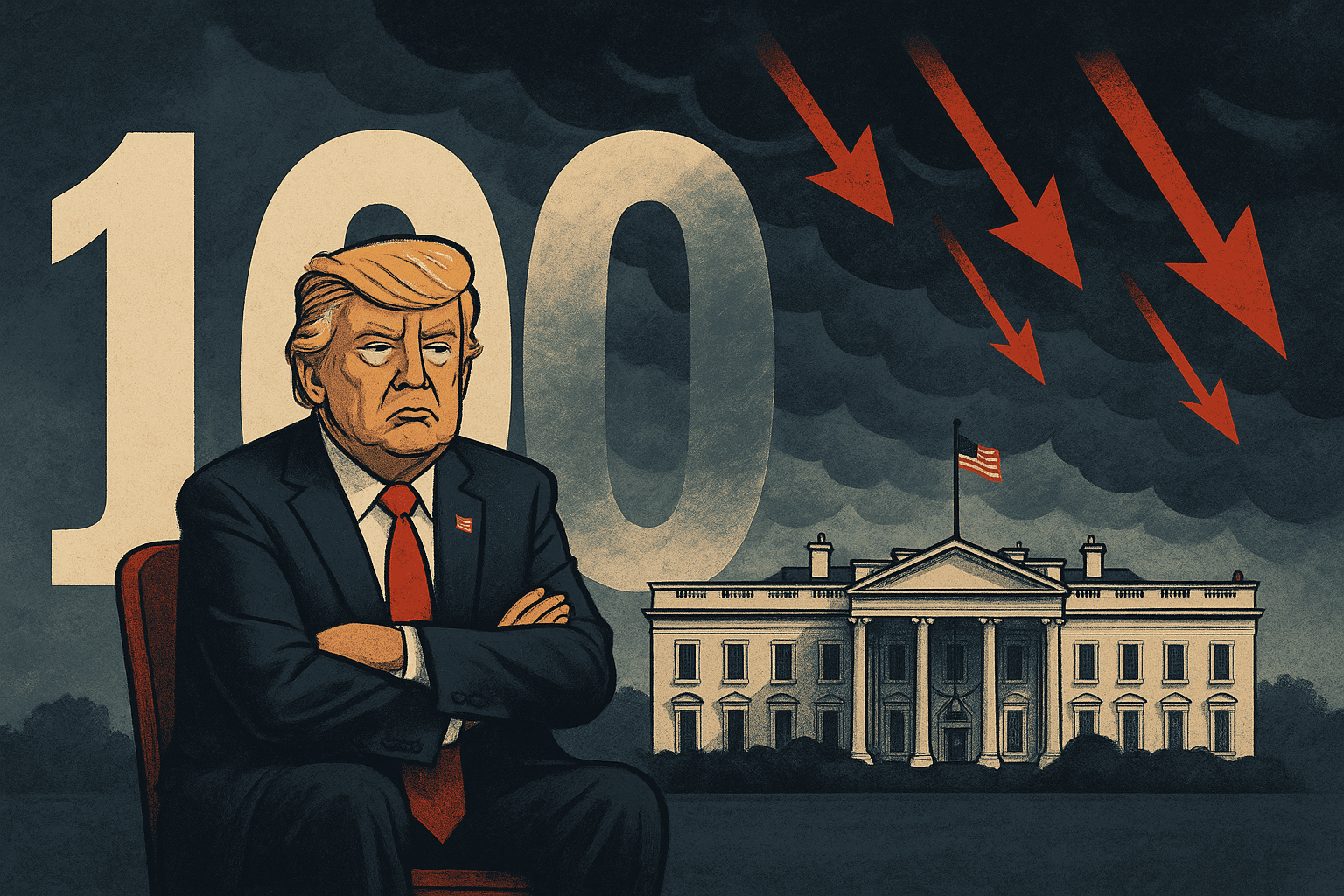
Dal 20 gennaio Donald Trump è tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato presidenziale. Nei primi cento giorni la sua Amministrazione ha preso decisioni controverse e senza precedenti, mettendo subito alla prova la propria stabilità. Fin dalle prime ore è apparso evidente che lo stile non sarebbe cambiato rispetto al primo quadriennio, anzi tutto il contrario: linguaggio muscolare, annunci su social prima dei canali istituzionali e un’agenda-shock in cui politica interna ed estera si intrecciano senza soluzione di continuità.
I dazi contro tutti: qual è la vera strategia?
La decisione più dirompente dei primi cento giorni della nuova Amministrazione è stata, senza dubbio, quella del 2 aprile 2025. In quella data il presidente Donald Trump ha proclamato il Liberation Day e annunciato l’introduzione di un dazio universale del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il deficit commerciale americano. Contemporaneamente ha previsto dazi "reciproci" più alti per circa sessanta Paesi, tra cui il 20% per l’Unione Europea e il 24% per il Giappone, che avrebbero dovuto entrare in vigore dal 9 aprile, tutti determinati da una formula diventata a dir poco controversa.
L’annuncio ha innescato una reazione immediatamente negativa sui mercati finanziari globali: il 4 aprile il Dow Jones ha perso 2.231 punti (-5,5%) e il Nasdaq quasi il 6%; anche le Borse europee e asiatiche hanno registrato cali significativi. A seguito di queste turbolenze, il 10 aprile Trump ha sospeso per 90 giorni l’applicazione dei dazi "reciproci" più elevati per tutti i Paesi, ad eccezione della Cina.
Questa sospensione temporanea ha l’obiettivo dichiarato di raggiungere accordi commerciali bilaterali. In realtà, benché Trump sostenga di essere vicino a firmare intese con alcune nazioni, finora non è stato concluso nulla di concreto. L’imprevedibilità del presidente rende, anzi, molti governi mondiali riluttanti a negoziare. Inoltre, mentre Trump afferma di aver aperto trattative anche con la Cina, Pechino lo ha pubblicamente smentito adottando una linea dura, convinta che gli Stati Uniti abbiano più bisogno delle merci cinesi che viceversa.
In tale contesto non è chiaro quale sia il vero fine di questa politica commerciale. Le imprese americane non sono, infatti, pronte a riportare rapidamente la produzione in patria: servirebbero tempo e manodopera, quest’ultima scarsa in un mercato del lavoro già saturo. Inoltre, la rilocalizzazione farebbe lievitare i costi, penalizzando soprattutto i consumatori statunitensi meno abbienti. Al momento, quindi, i dazi somigliano sempre di più ad un aumento d’imposta a carico degli stessi americani, in particolare dei più poveri.

Verso una crisi economica?
Che possa piacere o meno, le statistiche economiche mostrano che Donald Trump ha ereditato da Joe Biden un’economia solida e in crescita, sebbene con un’inflazione ancora non del tutto domata. Eppure l’annuncio sui dazi ha innescato incertezza e deteriorato rapidamente le aspettative di crescita.
Secondo diversi analisti, gli effetti reali dei nuovi dazi si avvertiranno soprattutto in estate. Come spiegato da Apollo Global Management, nei prossimi mesi approderanno negli Stati Uniti container carichi di merci cinesi soggette ai nuovi dazi; i prezzi più alti ridurranno le vendite e freneranno l’economia. Una volta esaurite le scorte, le imprese taglieranno gli ordini, causando un crollo delle importazioni e un calo dell’occupazione nei settori commerciale e dei trasporti, con il rischio concreto di innescare una recessione.
Non basta: l’incertezza sulle politiche di Trump sta già rallentando anche gli investimenti. Per le aziende è razionale rimandare nuovi progetti, contribuendo a sua volta a ridurre la crescita e ad aumentare la probabilità di recessione. A complicare il quadro interviene anche l’aumento dei tassi sui titoli di Stato americani, frutto della minore fiducia degli investitori nel governo. Questo rialzo è particolarmente problematico: anni di politiche espansive hanno portato il debito pubblico oltre il 120 % del PIL, facendo impennare i costi di rifinanziamento.
La combinazione di consumi in calo, investimenti in frenata, maggiori oneri finanziari e crescente instabilità delinea uno scenario sempre più fragile. Se tali tendenze dovessero consolidarsi nei prossimi mesi, all’orizzonte potrebbe profilarsi una dura crisi economica o, in alternativa, una stagflazione, vale a dire quella pericolosa miscela di stagnazione economica ed inflazione che rende assai più complesso l’intervento di governi e banche centrali.
Come Trump punta a isolare la Cina
Come già accennato, tra i Paesi più colpiti dalla nuova linea commerciale di Donald Trump spicca senza dubbio la Cina. L’ostilità del presidente verso Pechino non è nuova: già nella campagna elettorale del 2016 aveva denunciato con forza le pratiche cinesi, bollate come scorrette e sleali. Nel 2018 la Casa Bianca introdusse dazi del 25 % sull’acciaio e del 10 % sull’alluminio, cui si affiancarono dazi fino al 50% su pannelli solari, lavatrici e veicoli elettrici. L’allora Rappresentante per il Commercio, Robert Lighthizer, definì il forced technology transfer imposto da Pechino come un "comportamento irragionevole e discriminatorio", suscitando una pronta ritorsione cinese.
Con l’insediamento di Joe Biden, nel gennaio 2021, non arrivò però l’ampio ritiro dei dazi che molti attendevano: anzi la nuova Amministrazione democratica mantenne gran parte delle tariffe della Section 301 e nel 2024 le irrigidì su alcuni semiconduttori strategici. Gli allentamenti si limitarono a qualche esenzione su componenti intermedi e a licenze d’importazione mirate.
Una volta rientrato alla Casa Bianca, Trump ha inaugurato una fase di pressione ancora più severa nei confronti di Pechino. Il 1º febbraio ha imposto un ulteriore dazio del 10% su tutte le importazioni cinesi, motivandolo con la crisi del fentanyl; il 4 marzo ha replicato con un altro 10% e, il 4 aprile, con un altro aumento del 34%, portando l’aliquota effettiva complessiva al 54%. Poiché questi nuovi dazi si sommano alle tariffe precedenti, su alcuni prodotti l’imposizione reale superava già l’80%.
La Cina ha reagito il 9 aprile, portando all’84% i dazi su energia, componenti aeronautici e semiconduttori statunitensi; tre giorni dopo ha innalzato l’aliquota media complessiva al 125 %. Fra il 13 e il 15 aprile la Casa Bianca ha contrattaccato, estendendo i propri dazi a un paniere più ampio di beni cinesi fino al 145%. E' evidente che a questi livelli il commercio bilaterale perde ogni convenienza economica, trasformandosi in una prova di pura resistenza politica.
Secondo Trump, tuttavia, questa stretta senza precedenti dovrà costringere Xi Jinping a sedersi al tavolo "a condizioni realistiche". In tal modo l’Amministrazione intende trasformare l’arma commerciale in leva di politica estera, sostituendo alla forza militare un regime di coercizione economica destinato a confinare Pechino ai margini dei circuiti globali.
La strategia della Casa Bianca fa leva anche sulle fragilità interne della seconda economia del pianeta: disoccupazione giovanile oltre il 16%, mercato immobiliare in crisi cronica, deflazione sui beni di largo consumo, fuga di capitali esteri (-27% di afflussi netti nel 2024) e nascite ai minimi storici. In un contesto tanto delicato, Trump scommette, quindi, che un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali costerà più di quanto Pechino sia disposta a sopportare, rafforzando così la posizione negoziale degli Stati Uniti.
Non è però escluso neppure l’esito opposto: a Pechino si confida nella capacità dell’apparato produttivo e del sostegno statale di assorbire lo shock tariffario più a lungo di quanto i consumatori americani siano pronti a tollerare. I primi segnali sembrano avvalorare questa ipotesi: nel primo trimestre gli utili industriali cinesi sono tornati a crescere (+0,8%), mentre il governo di Pechino ha appena varato un nuovo pacchetto di stimoli fiscali e monetari per sostenere consumi e investimenti, alimentando la narrazione di una resilienza cinese superiore a quella americana.