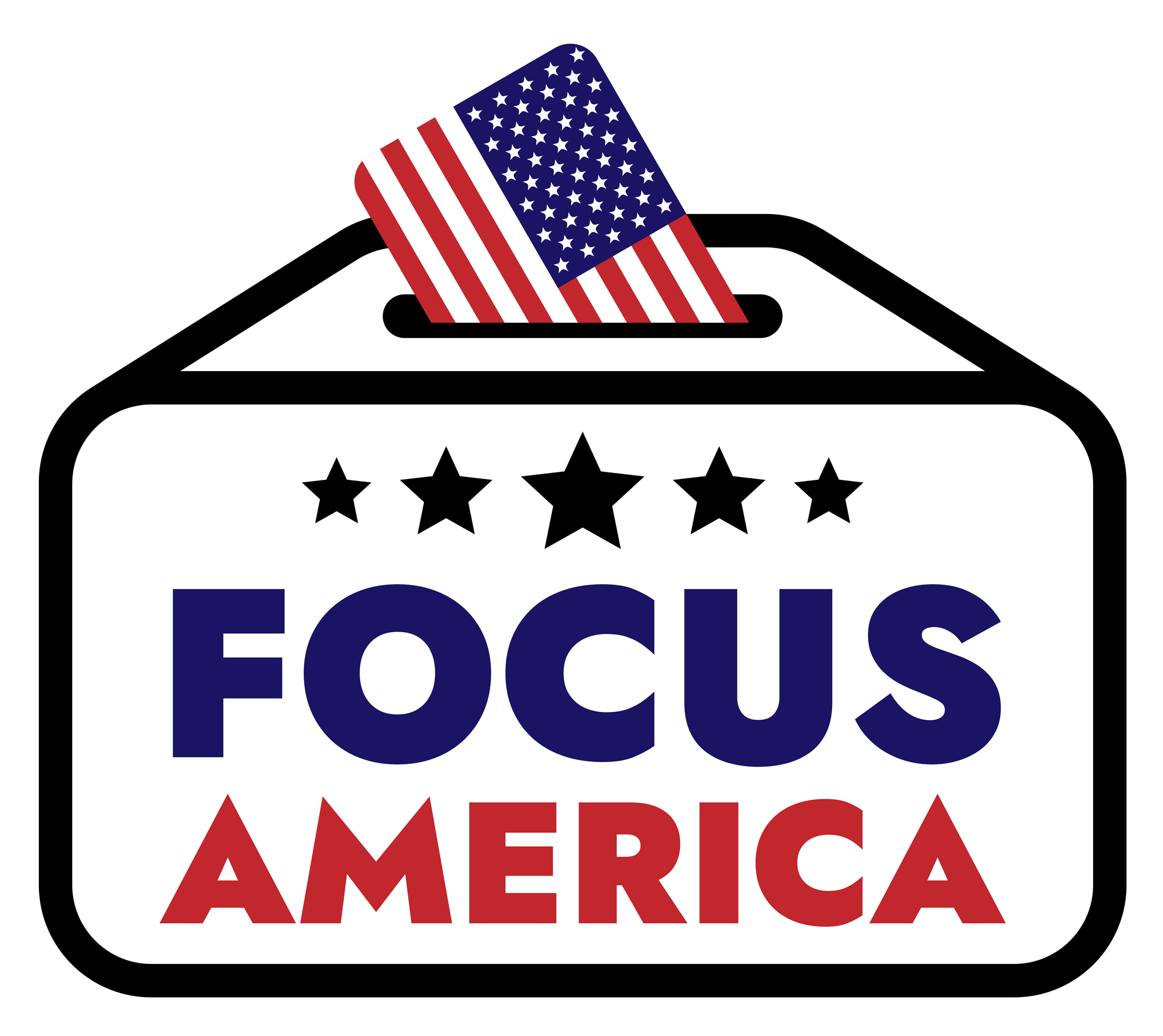Trump tra attacchi all’Iran e promesse di pace: l’ambiguità strategica del presidente
Dopo aver ordinato il bombardamento di tre siti nucleari iraniani, Trump afferma di voler “fermare la guerra”. Ma negli Stati Uniti e all’estero crescono le perplessità sulla legittimità e l’efficacia dell’operazione.

Il presidente Donald Trump ha annunciato con solennità un’operazione militare americana contro tre siti nucleari iraniani – Natanz, Isfahan e Fordo – presentandola come un “successo militare spettacolare”. Secondo il capo di stato maggiore Dan Caine, l’operazione sarebbe stata altamente complessa e condotta nel massimo riserbo. Tuttavia, gli effetti concreti dell’offensiva restano incerti.
Il presidente ha dichiarato che gli impianti colpiti sono stati “completamente e totalmente annientati”, ma fonti militari hanno parlato di “danni estremamente severi”, senza poter confermare l’impatto reale sulle strutture sotterranee. Immagini satellitari mostrano evidenti crateri, ma non è possibile verificare se l’Iran abbia protetto le centrifughe o spostato l’uranio arricchito in altri luoghi segreti. Il vicepresidente J. D. Vance ha riconosciuto indirettamente queste incertezze, affermando che gli Stati Uniti lavoreranno per “assicurarsi che qualcosa venga fatto riguardo a quel combustibile”.
Il presidente ha cercato di inquadrare l’operazione come parte della sua strategia di pace. Ma la sua base elettorale resta in gran parte contraria a nuovi conflitti esteri. Durante la campagna, Trump ha promesso una politica di disimpegno e attenzione agli interessi interni. Per questo, nelle dichiarazioni successive all’attacco, la Casa Bianca ha insistito sul carattere “limitato e mirato” dell’azione. Secondo Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, l’obiettivo non era l’Iran, ma esclusivamente il suo programma nucleare. Entrambi hanno escluso qualsiasi intenzione di voler un cambio di regime a Teheran.
Eppure, le contraddizioni emergono chiaramente. Trump ha fatto riferimento al suo slogan “Make America Great Again” anche durante l’operazione, indossando un cappellino MAGA nella situation room e scegliendo la East Room della Casa Bianca – lo stesso luogo da cui Barack Obama annunciò la morte di Osama bin Laden – per il suo discorso alla nazione. L’enfasi sulla messa in scena e la spettacolarizzazione della forza suggerisce che il presidente intenda rafforzare la sua immagine di “comandante in capo” forte e deciso.
L’analisi dell’azione americana rivela inoltre un’influenza crescente della dottrina militare israeliana. In particolare, Trump sembra aver adottato la cosiddetta “dottrina Begin”, dal nome dell’ex primo ministro israeliano che nel 1981 ordinò il bombardamento preventivo della centrale nucleare di Osirak in Iraq. L’idea alla base è quella di agire in via preventiva per impedire a un potenziale nemico di acquisire capacità nucleari. Anche in questo caso, gli Stati Uniti hanno tentato per sessanta giorni di ottenere una “capitolazione incondizionata” dell’Iran sul programma di arricchimento, ma senza successo.
La componente ideologica dell’operazione emerge anche dalla marginalizzazione di alcune figure chiave nel panorama della sicurezza nazionale americana. Tulsi Gabbard, ex democratica e direttrice dell’intelligence nazionale, è stata progressivamente messa da parte. A marzo, aveva dichiarato che l’Iran non stava sviluppando una bomba atomica e che il programma era stato sospeso dal 2003. Le sue affermazioni coincidevano con l’opinione condivisa da molti esperti, ma sono apparse incompatibili con l’allarmismo crescente dell’amministrazione. Non a caso, Marco Rubio ha invitato pubblicamente a “dimenticare il lavoro dell’intelligence” e a concentrarsi sull’obiettivo politico.
L’operazione contro l'Iran si inscrive così in una dinamica che va oltre la semplice deterrenza: è una prova di forza che punta a ribadire il primato americano nella gestione della sicurezza globale, anche a costo di violare norme internazionali. Per molti osservatori, si tratta di un atto unilaterale che solleva interrogativi sulla legalità dell’uso della forza e sulle reali intenzioni strategiche di Washington.
Le reazioni interne non sono unanimi. Una parte del Partito Repubblicano ha espresso preoccupazioni, mentre manifestazioni contro la guerra si sono svolte in diverse città americane, tra cui Los Angeles. Anche la stampa conservatrice, come il Wall Street Journal, pur elogiando l’azione, riconosce che l’operazione potrebbe aprire scenari instabili. Il quotidiano ha definito “sbagliati” gli isolazionisti che avevano previsto un’escalation simile all’Iraq, ma ha ammesso che il rischio di un conflitto più ampio non può essere escluso.
Nelle ore successive all’attacco, Trump ha continuato a rilanciare il messaggio su Truth Social, parlando di un “successo militare spettacolare” e domandandosi se non fosse giunto il momento per un “cambio di regime” a Teheran. La distinzione tra operazione militare mirata e ambizione politica sembra così assottigliarsi, alimentando il sospetto che l’azione serva anche a consolidare il consenso interno in vista della rielezione.
Mentre i bombardamenti sono finiti, restano sul tavolo molte incognite: l’effettiva capacità dell’Iran di riprendere rapidamente il proprio programma nucleare, la possibilità di ritorsioni dirette contro obiettivi americani o israeliani, e l’eventuale inasprimento del confronto diplomatico con altre potenze coinvolte nell’accordo sul nucleare iraniano. In questo scenario, il “grande equilibrio” evocato da Trump tra pace e forza rischia di diventare una pericolosa ambiguità.