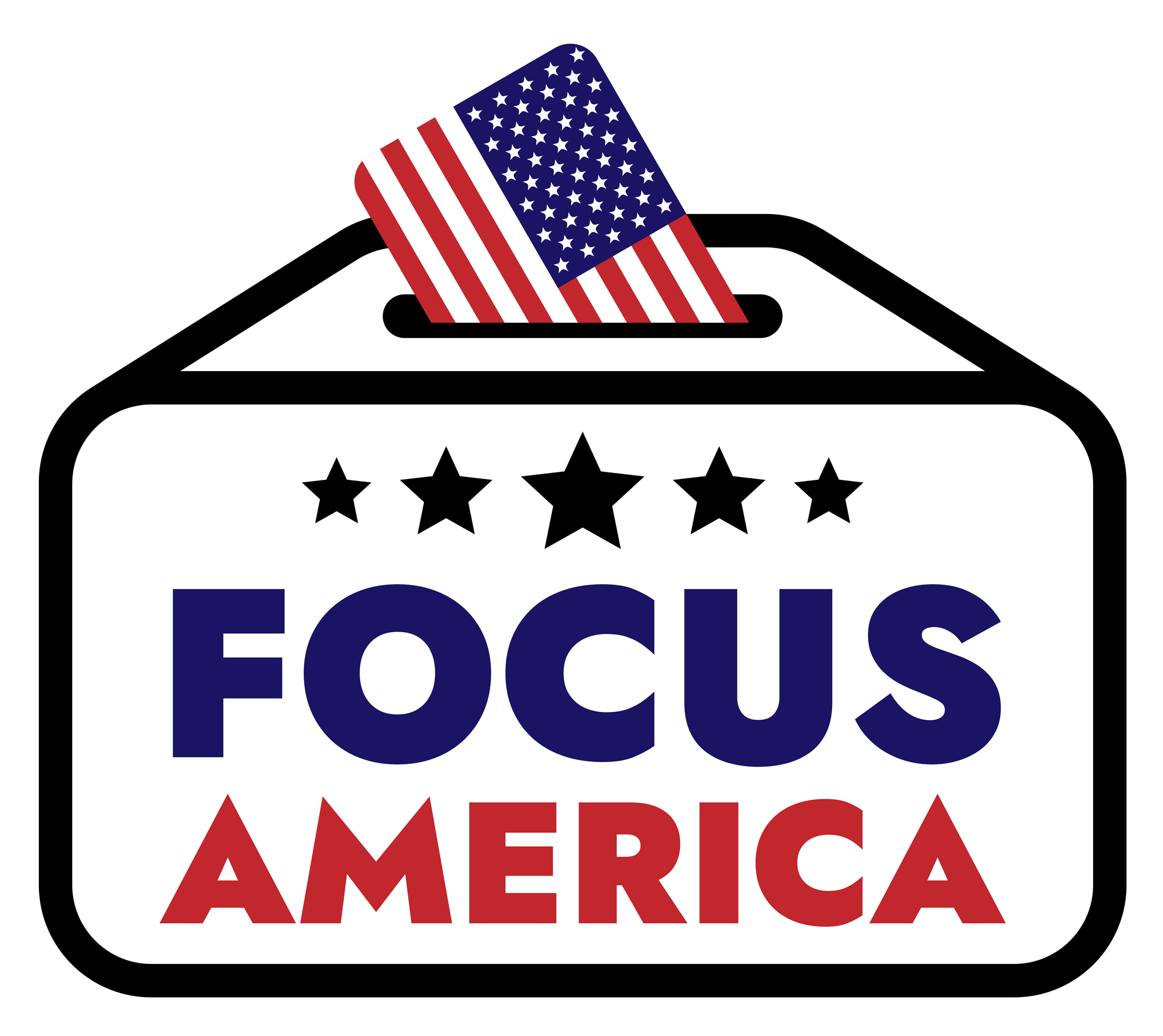Trump e i dazi: una strategia ideologica dietro il caos commerciale
Dietro l'apparente disordine delle misure protezionistiche del presidente Donald Trump si cela una visione strutturata della politica economica e internazionale statunitense, radicata nella storia e destinata a perdurare.

Nonostante il caos generato dalla nuova ondata di dazi imposti dagli Stati Uniti sotto la presidenza Trump, la strategia commerciale adottata non è il frutto di improvvisazione, ma di una dottrina ideologica precisa e coerente. Questo è quanto emerge dall’analisi pubblicata da Le Monde, che cerca di capire le motivazioni profonde dietro l’attuale politica economica e di sicurezza americana.
Rispetto al primo mandato, l’approccio del presidente è mutato in intensità, pur restando fedele alla linea originaria. Se nel 2016 le proposte di Trump potevano sembrare provocatorie e teatrali, nel 2025 assumono un carattere esecutivo, segnando il passaggio da una politica “da show” a una vera e propria offensiva contro l’ordine mondiale stabilito dopo la guerra fredda. Le contraddizioni presenti nelle misure annunciate – come l’imposta impossibile da sostituire con i soli dazi o il progetto di tassare le importazioni dai territori antartici – non devono distrarre dall’idea centrale: il ritorno a una politica protezionista, autarchica e imperiale.
Al centro di questa strategia c’è la riscoperta del pensiero di William McKinley, presidente statunitense alla fine del XIX secolo e promotore di un forte protezionismo economico. Trump ha elevato McKinley a figura simbolica del suo programma, arrivando a ripristinare il suo nome sul monte più alto dell’Alaska, una decisione dal forte valore simbolico rispetto al ribattezzamento in “Denali” voluto da Barack Obama nel 2015.
Il riferimento a quel periodo storico non si limita alla politica commerciale. L’attuale presidenza rievoca anche l’imperialismo del cosiddetto Gilded Age, promuovendo una visione di egemonia regionale ispirata alla dottrina Monroe del 1823. Le rivendicazioni sul controllo del traffico marittimo attraverso il canale di Panama, l’interesse per il Groenlandia e la messa sotto pressione del Canada sono esempi concreti di una strategia che punta a rafforzare la supremazia americana nell’emisfero occidentale.
Nonostante i dubbi sulle modalità di attuazione, questa impostazione trova un certo consenso strategico negli Stati Uniti. La reazione di Pechino, irritata dalla cessione dei porti panamensi a Washington, è una conferma indiretta della rilevanza geopolitica di queste azioni. In questo contesto, Trump si affida alla forza economica e tecnologica del paese, alimentata dall’indipendenza energetica raggiunta grazie al gas di scisto, per sostenere una politica semi-autarchica.
Questa visione non è estranea nemmeno al Partito Democratico. Già nel 2023 Jake Sullivan, allora consigliere alla sicurezza nazionale di Joe Biden, aveva delineato la necessità di un “nuovo consenso” dopo la crisi finanziaria, la pandemia e la guerra in Ucraina, evidenziando i limiti del modello globalista. Trump si inserisce in questa tendenza, ma ne estremizza i contenuti, sostituendo gli incentivi alle imprese con minacce di sanzioni per chi non investe negli Stati Uniti.
La coerenza ideologica di Trump si riflette anche nella sua ossessione storica per il deficit commerciale. Fin dal 1987, quando acquistò una pagina pubblicitaria sul New York Times per accusare il Giappone di approfittarsi degli Stati Uniti, il futuro presidente aveva mostrato attenzione per gli squilibri nei rapporti economici globali. Oggi, con un deficit ancora elevato e un dollaro considerato sopravvalutato, la sua amministrazione cerca di riequilibrare i conti anche forzando gli altri paesi a finanziare l’economia americana.
Tuttavia, questa teoria sta incontrando due ostacoli principali. Da un lato, la Cina ha mostrato di non volersi piegare alle pressioni americane, consolidando la propria posizione negoziale. Dall’altro, l’instabilità creata dalla politica trumpiana ha allarmato i mercati finanziari, provocando il crollo di Wall Street e una perdita di fiducia nel dollaro e nei titoli di Stato.
Il sentimento di rivalsa, che attraversa tutta la retorica di Trump, si basa sulla convinzione che l’America sia stata umiliata dalla globalizzazione. Nonostante la crescita dell’economia e il complessivo arricchimento americano, l’occupazione industriale è rimasta stagnante, mentre negli ultimi trent'anni milioni di posti di lavoro sono stati persi nel manifatturiero a vantaggio del settore dei servizi. Questo processo ha lasciato segni profondi nelle regioni della “Rust Belt”, fornendo a Trump un solido bacino elettorale tra gli ex operai.
Nel complesso, il trumpismo si presenta come una dottrina consolidata e potenzialmente duratura. Anche qualora Donald Trump dovesse perdere credibilità o influenza, la visione che incarna – fatta di protezionismo, rifiuto del multilateralismo e rilancio dell’autorità americana – potrebbe continuare a plasmare la politica degli Stati Uniti negli anni a venire.