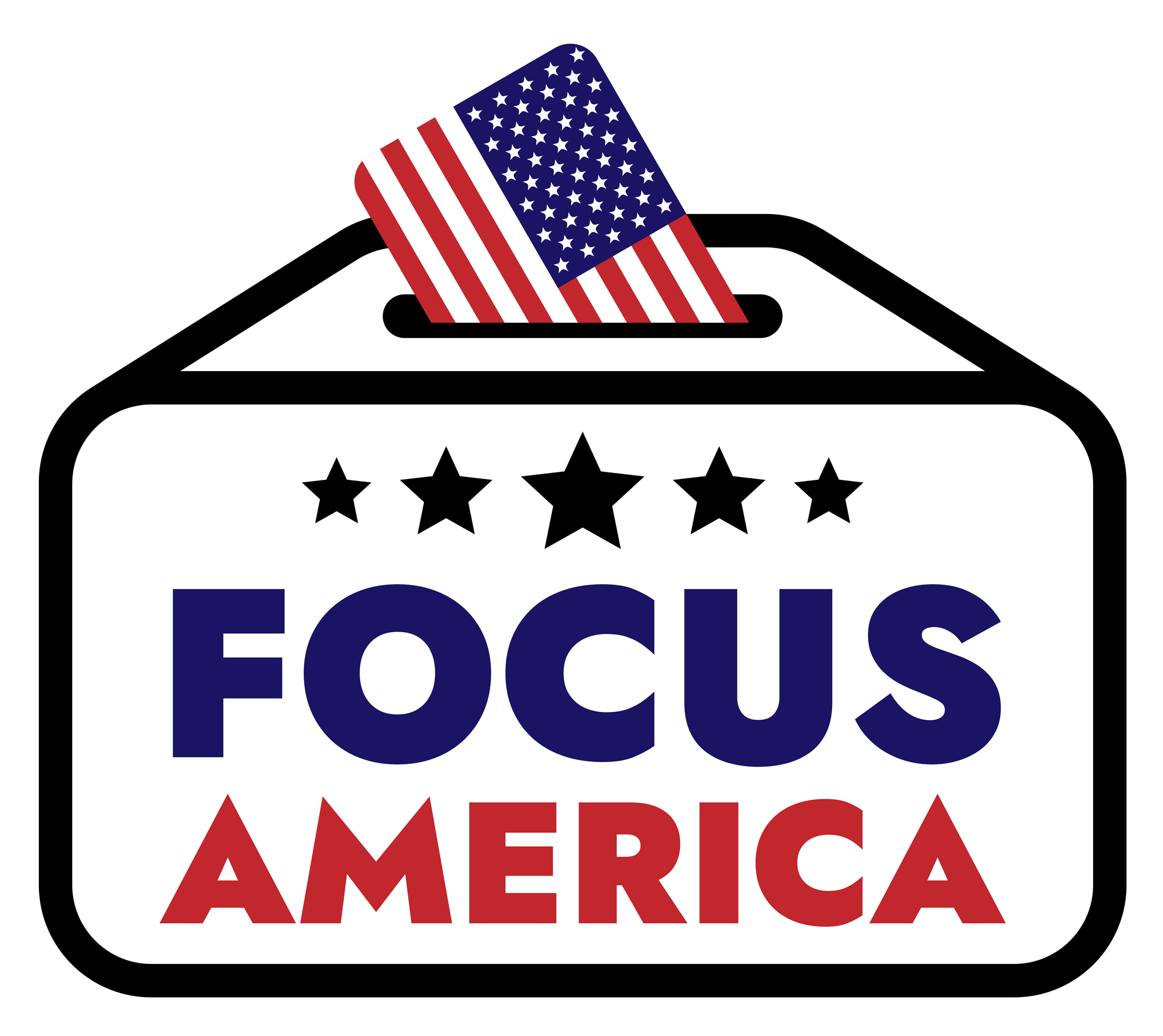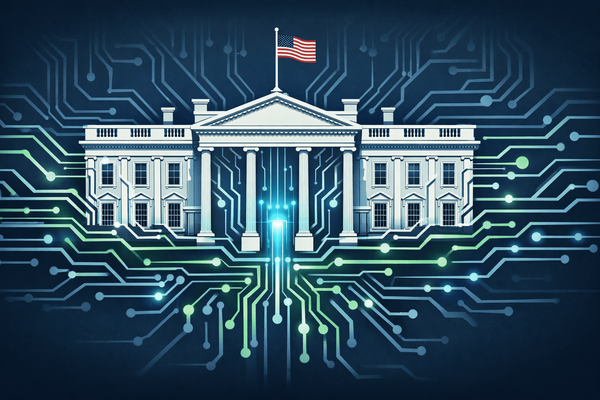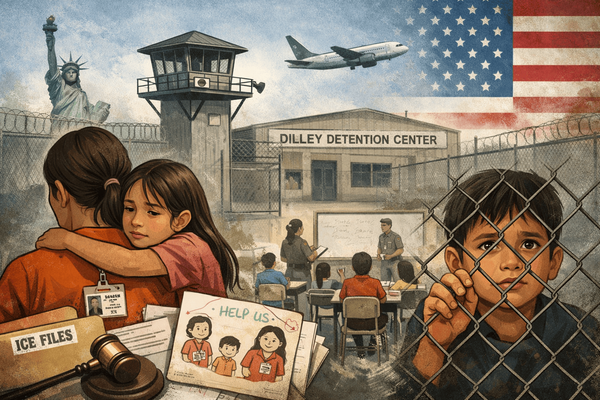Trump decide nuovi dazi dal 7 agosto
Il presidente impone nuove tariffe tra il 15% e il 50% alla maggior parte dei partner commerciali, punendo politicamente Brasile, India, Canada e Svizzera. Accordi raggiunti con UE, Giappone e altri alleati asiatici.

Con un decreto firmato il 31 luglio alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha confermato l’introduzione di nuove ondate di dazi doganali, applicabili a partire dal 7 agosto. Sebbene il termine per raggiungere nuovi accordi commerciali fosse inizialmente fissato al 1° agosto, la scadenza è stata prorogata di sei giorni per permettere alle dogane statunitensi di prepararsi all’esecuzione delle misure. Le nuove tariffe si situano in un range compreso tra il 15% e il 41%, con punte settoriali fino al 50%, e colpiscono oltre sessantanove paesi a livello globale.
Il nuovo piano tariffario rappresenta il secondo tentativo in pochi mesi da parte dell’amministrazione Trump di ristrutturare l’ordine commerciale globale a favore dell’economia statunitense. Le misure annunciate ad aprile erano state sospese dopo le turbolenze sui mercati finanziari. Stavolta, però, il presidente ha deciso di procedere, seppur con una breve proroga e con alcuni adeguamenti per Paesi strategici.
I dazi più alti colpiscono la Siria (41%), la Birmania e il Laos (40%), la Svizzera (39%) e la Serbia e l’Iraq (35%). Tra i Paesi puniti con i tassi più severi c’è il Brasile, che subisce un dazio del 50%. Secondo l’amministrazione americana, il Paese sudamericano rappresenterebbe una "minaccia straordinaria" per la sicurezza nazionale e l’economia degli Stati Uniti, a causa delle inchieste contro Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato. Anche l’India viene colpita con un dazio del 25%, accompagnato da una “penalità” per i suoi rapporti commerciali con la Russia, in particolare per le forniture di energia e armamenti.
Al contrario, Washington ha concesso un trattamento più favorevole ai Paesi del Sud-Est asiatico che si sono rivelati alleati strategici per contenere l’influenza della Cina. Il Vietnam, inizialmente colpito da una tariffa del 46%, è riuscito a negoziare un dazio ridotto al 20%. Anche Cambogia e Thailandia hanno ottenuto una riduzione da 36% a 19%. Taiwan, da parte sua, ha annunciato che cercherà un ulteriore abbassamento dopo la riduzione dal 32% al 20%.
Tra gli accordi già formalizzati ci sono quelli con il Regno Unito, che ha ottenuto l’abbassamento delle tariffe al 10% su gran parte dei beni esportati, e con l’Unione europea. L’accordo UE-USA, firmato il 27 luglio in Scozia da Trump e Ursula von der Leyen, prevede un dazio uniforme del 15% – inferiore rispetto al 30% inizialmente minacciato – e l’esenzione per il settore aeronautico e alcuni prodotti agricoli. In cambio, Bruxelles si è impegnata ad acquistare 750 miliardi di dollari in energia statunitense e a investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti.
Anche il Giappone ha accettato dazi al 15% evitando l’aumento al 25%, mentre Indonesia, Filippine e Corea del Sud hanno ottenuto accordi simili. La Corea, in particolare, ha salvaguardato il settore automobilistico, che rimarrà tassato al 15%.
Canada, Svizzera, India e Brasile sono invece tra i principali partner commerciali a non aver raggiunto un’intesa con Washington. Il Canada, dopo l’annuncio del suo sostegno alla creazione di uno Stato palestinese, ha visto salire le tariffe dal 25% al 35% su tutti i beni non coperti dall’accordo Aceum (il patto di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico). Il governo canadese ha inoltre introdotto una tassa sui servizi digitali e sospeso i colloqui commerciali in giugno, alimentando una tensione diplomatica già marcata.
La Svizzera subisce un aumento delle tariffe dal 31% al 39%, nonostante l’accordo preliminare firmato il 4 luglio. Il governo elvetico attende ora l’approvazione formale da parte di Washington. Per un’economia fortemente orientata all’export farmaceutico, orologiero e alimentare, si tratta di un colpo significativo.
Nei confronti del Messico, partner essenziale per l’industria americana e per la gestione della frontiera, il presidente ha scelto un approccio più flessibile. Dopo un colloquio con la presidente Claudia Sheinbaum, Trump ha prorogato di 90 giorni le tariffe attualmente in vigore (25%), escludendo le esportazioni conformi all’Aceum.
La Cina, invece, resta in una posizione ambigua. Dopo mesi di tensioni, le due potenze hanno avviato negoziati a Stoccolma, ma senza risultati concreti. Trump ha lasciato intendere che è interessato a un accordo più ampio e strutturale con Pechino, anche per raffreddare i suoi legami con la Russia. Il Wall Street Journal ha evocato la possibilità di una “offerta nixoniana”, paragonando l’attuale apertura a quella operata da Richard Nixon nel 1972 per isolare l’URSS. Washington ha già dato segnali di distensione, autorizzando l’export di chip Nvidia e scoraggiando un transito del presidente taiwanese sul suolo americano.
A livello interno, la decisione di Trump è stata accolta con riserve. I mercati finanziari hanno reagito con un leggero calo, molto più contenuto rispetto al crollo di aprile. Tuttavia, sul piano legale, la manovra potrebbe essere vulnerabile: la Corte federale d’appello ha mostrato scetticismo sull’uso della legge d’emergenza del 1977 per giustificare i dazi, come già evidenziato in primo grado a New York. L’esito finale delle procedure giudiziarie resta incerto, ma nel frattempo la maggior parte dei partner commerciali ha accettato le condizioni imposte da Washington.
Infine, la Casa Bianca ha annunciato due ulteriori misure: l’imposizione di un dazio del 50% sui prodotti contenenti rame – ma non sul metallo grezzo – per stimolare la produzione nazionale, e la soppressione, dal 29 agosto, dell’esenzione fiscale sui pacchi postali di valore inferiore agli 800 dollari.