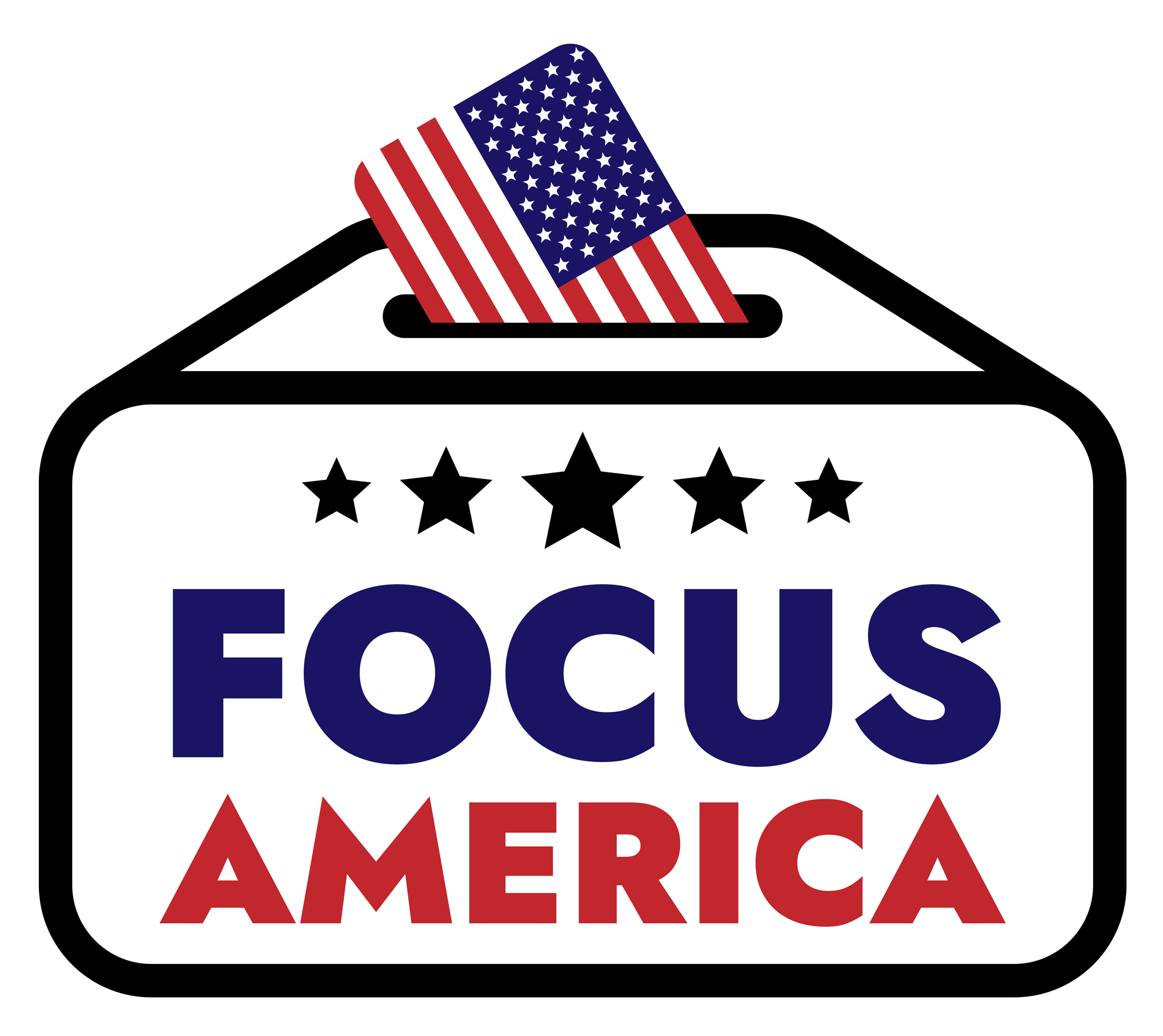Perché i governi populisti portano avanti politiche impopolari
Non governano per essere popolari, ma per mantenere alta la rabbia
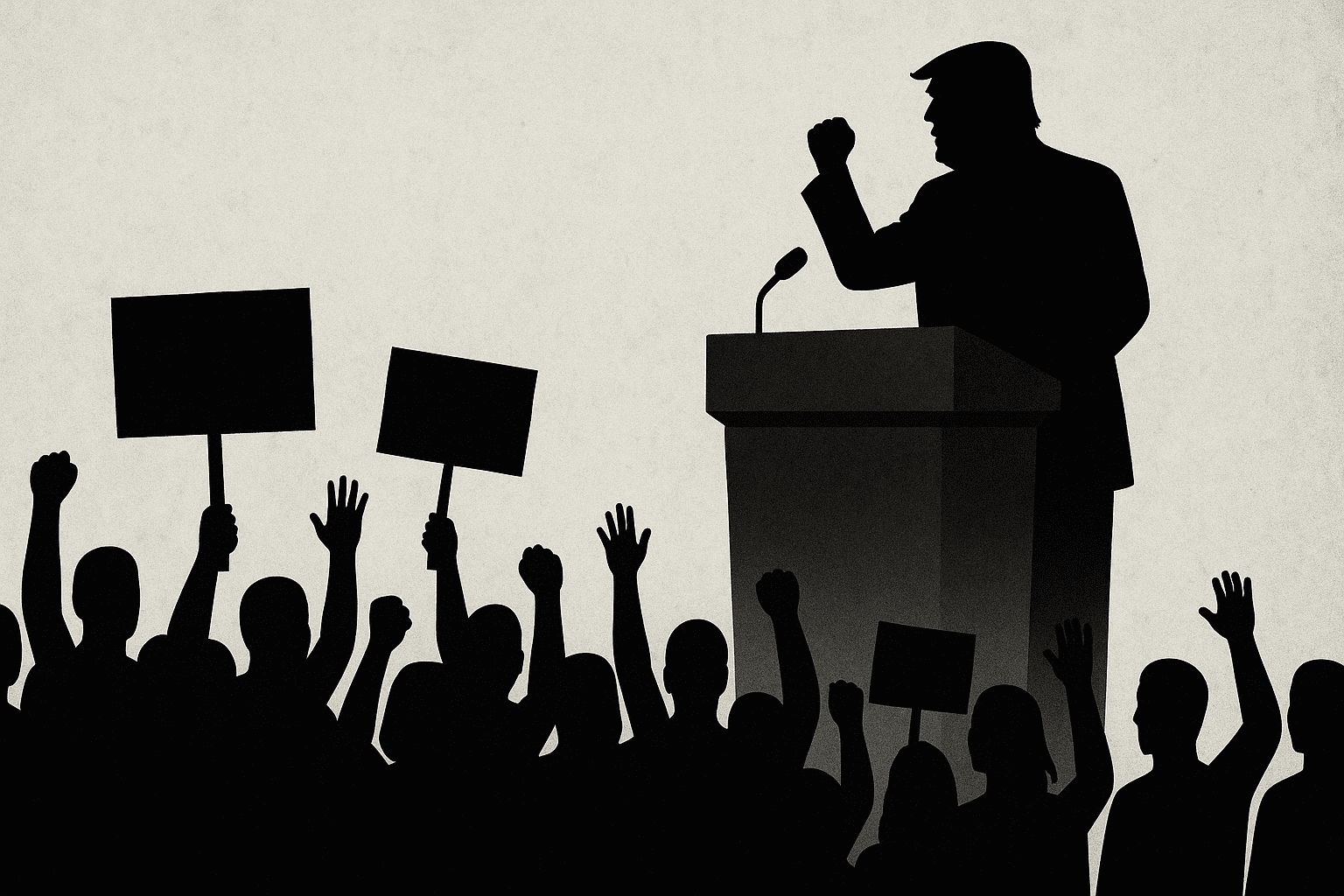
Dopo dieci anni dalla sua entrata in politica, Donald Trump continua a essere la figura centrale della politica statunitense. Il Big Beautifull Bill che ha fatto approvare al Congresso rappresenta una svolta: è una legge estremamente impopolare, con costi elevati senza precedenti, che favorisce i ceti più ricchi penalizzando i più poveri. Ma come può un leader populista, salito al potere cavalcando la frustrazione popolare, adottare misure che alimentano proprio quelle diseguaglianze sociali che avevano originato il malcontento?
La risposta, secondo l’analisi di Jennifer Nicoll Victor, professoressa di scienze politiche presso la George Mason University, su Mischiefs of Faction, risiede nella logica stessa del populismo: una strategia politica che non si fonda sulla popolarità, ma sulla divisione sociale, sulla rabbia e sull’identificazione di un nemico comune.
Il populismo non è un’ideologia
Il populismo non è un’ideologia nel senso tradizionale. Può provenire da movimenti conservatori o liberali. La sua caratteristica principale è la costruzione di un’identità collettiva tra coloro che si percepiscono come oppressi da “élite” più potenti. Queste élite possono essere leader aziendali, funzionari pubblici, giornalisti, scienziati o accademici: il populismo adatta i propri bersagli in funzione del contesto. Ciò che accomuna tutte le sue forme è la retorica dicotomica del “noi contro loro”.
Questo schema trova terreno fertile in società caratterizzate da forti diseguaglianze economiche e polarizzazione politica, come gli Stati Uniti degli ultimi quarant’anni. Il populismo indirizza il risentimento di gruppi già divisi contro figure o gruppi identificati come nemici: immigrati, ricchi, esperti, politici.
La versione conservatrice del populismo si basa su un nazionalismo identitario: “noi” è il popolo nativo, “loro” sono gli immigrati. Nella variante di sinstra, invece, “noi” è composto da gruppi oppressi, mentre “loro” sono le élite finanziarie. Entrambe le versioni, scrive Victor, possono assumere tratti antidemocratici, perché puntano a disumanizzare o punire categorie della popolazione, minando i principi di uguaglianza e stato di diritto.
La struttura emotiva del confronto
Una chiave interpretativa utile arriva dalla psicologia sociale. Gli studi di Meghan Condon e Amber Wichowsky evidenziano che i confronti sociali influenzano profondamente il nostro umore e comportamento. Confrontarsi verso l’alto (con chi sta meglio) genera frustrazione e invidia. Confrontarsi verso il basso (con chi sta peggio) suscita invece sensazioni di superiorità e soddisfazione.
Nel populismo conservatore, il confronto è verso il basso: il gruppo nemico è descritto come indegno o pericoloso, inferiore rispetto al gruppo dominante. Questo meccanismo alimenta il senso di identità positiva del “noi” e fornisce un facile capro espiatorio. Il populismo di sinistra, al contrario, incoraggia confronti verso l’alto, più dolorosi, perché puntano il dito contro le diseguaglianze e il potere economico. Per questo, secondo Victor, il populismo conservatore tende ad avere maggiore presa: genera emozioni più gratificanti, alimentando un ciclo di appartenenza e risentimento.
Il populismo non risolve i problemi, li mantiene
Una volta consolidato il potere, il leader populista ha tutto l’interesse a conservare intatta la struttura emotiva che lo ha sostenuto. Non cerca il consenso attraverso politiche redistributive, ma attraverso la costante identificazione di nemici. La sopravvivenza del populismo, in altre parole, dipende dal mantenimento delle diseguaglianze che generano il malcontento popolare. Per questo, osserva Victor, non è un caso che l’amministrazione Trump abbia investito risorse e attenzione in politiche migratorie aggressive e disumanizzanti, con la costruzione di centri di detenzione che funzionano tanto come strumenti di espulsione quanto come simboli visivi del “noi contro loro”.
Questa logica si applica anche alla recente legge di bilancio, soprannominata Big Beautiful Bill. Secondo Victor, il provvedimento non affronta né corregge i principali fattori di diseguaglianza negli Stati Uniti. Non migliora l’accesso all’assistenza sanitaria, non riduce i costi abitativi, non sostiene le famiglie con figli o persone non autosufficienti. Al contrario, prevede tagli ai servizi sanitari, riduzioni fiscali per i più ricchi e un aumento del deficit. In un contesto in cui i giovani hanno prospettive economiche peggiori rispetto alle generazioni precedenti, la legge non fa che aggravare la situazione.
Il paradosso democratico
Ma se le politiche sono così impopolari, perché i leader populisti riescono comunque a conservarsi al potere? Una delle spiegazioni proposte è che, all’interno delle democrazie, le elezioni non rappresentano lo strumento più efficace di controllo politico. Gli studi di Christopher Achens e Larry Bartels mostrano che gli elettori hanno una memoria corta, sono influenzabili da appelli emotivi e tendono ad agire in modo reattivo più che razionale.
In questo quadro, proteste sociali e un giornalismo indipendente rappresentano strumenti di responsabilizzazione più efficaci delle elezioni. Ma se questi strumenti vengono indeboliti o delegittimati, i leader populisti riescono a muoversi con maggiore libertà, ignorando l’opinione pubblica e mantenendo il proprio seguito attraverso la polarizzazione.
La logica che guida il populismo, conclude Victor, non è quella della rappresentanza o dell’efficienza, ma quella della divisione. Non importa se le politiche peggiorano le condizioni materiali del proprio elettorato. Importa che le condizioni restino abbastanza difficili da alimentare la frustrazione, che può poi essere incanalata verso i nemici indicati dal leader. La razionalità, in questo schema, è un ostacolo. E finché il populismo dominerà uno dei due grandi partiti americani, ci si può aspettare che le politiche pubbliche servano a perpetuare la rabbia, non a risolverne le cause.