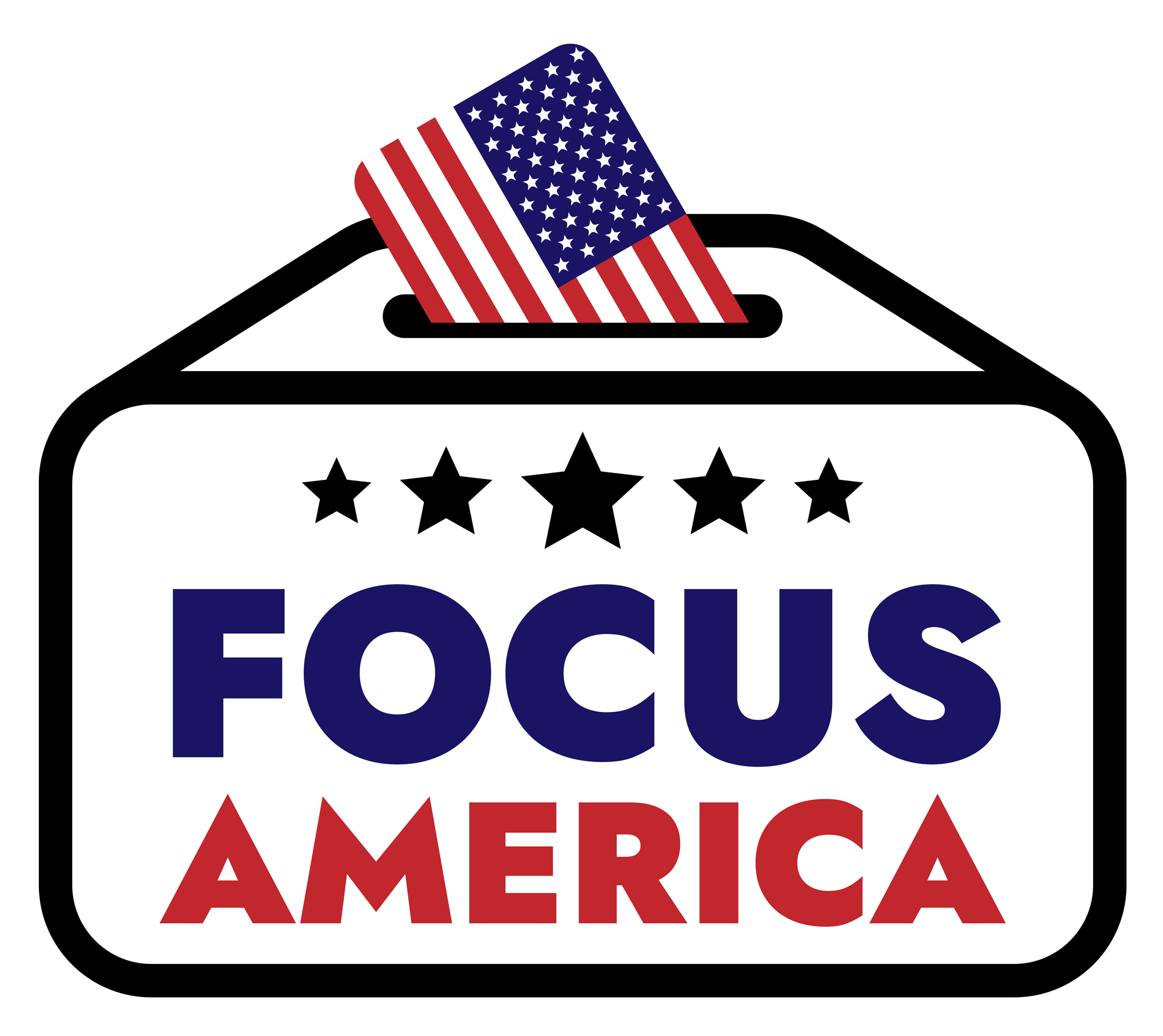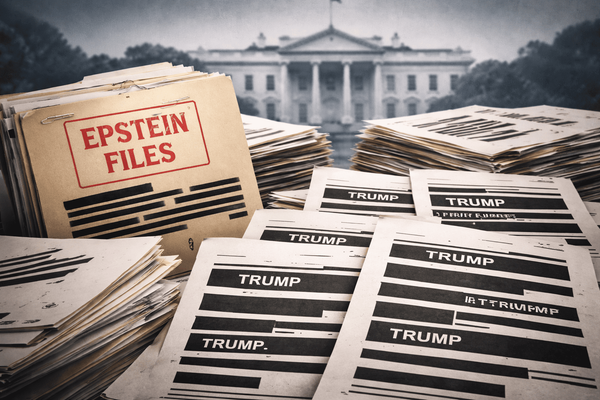Nagasaki, 80 anni dopo: il secondo lampo atomico che piegò il Giappone
Il 9 agosto 1945, tre giorni dopo Hiroshima, un B-29 statunitense sganciò la bomba Fat Man sulla città portuale di Nagasaki. Fu l’ultimo impiego bellico di un’arma nucleare nella storia, e accelerò la resa giapponese.

Il 9 agosto 1945, alle 11:02 del mattino, un bombardiere statunitense B-29 chiamato Bockscar sganciò sulla città di Nagasaki una bomba atomica al plutonio, soprannominata Fat Man. Era il secondo impiego nella storia di un’arma nucleare, avvenuto appena tre giorni dopo Hiroshima. L’esplosione trasformò in rovine un porto industriale vitale per l’economia e lo sforzo bellico giapponese, provocando decine di migliaia di morti e accelerando la fine della Seconda guerra mondiale nel Pacifico.
Dal piano originale all’obiettivo secondario
Il bersaglio designato inizialmente era Kokura, sede di depositi militari e fabbriche di armi. Quel mattino, però, il cielo era coperto e la città avvolta nel fumo provocato da un raid aereo del giorno prima. Dopo tre sorvoli senza visibilità sufficiente, l’equipaggio del Bockscar, con poco carburante e già in ritardo sulla tabella di marcia, si diresse verso l’obiettivo secondario: Nagasaki.
Questa città portuale del Kyūshū, con circa 240.000 abitanti, era un centro di costruzioni navali e produzione bellica — ospitava impianti Mitsubishi e cantieri navali strategici — ma non era stata scelta come primo bersaglio. Il destino la inserì nella storia nucleare del mondo per una combinazione di pianificazione militare e circostanze fortuite.
La geografia non bastò a salvarla
Nagasaki sorgeva in una valle stretta, circondata da colline. Questa conformazione avrebbe ridotto la portata dell’onda d’urto rispetto a Hiroshima, ma non impedì la distruzione. Alle 11:02, Fat Man esplose a circa 500 metri d’altezza sopra il quartiere di Urakami. La potenza sprigionata fu pari a 21.000 tonnellate di tritolo — più di Little Boy su Hiroshima — e generò una palla di fuoco di centinaia di metri di diametro.
L’esplosione distrusse ogni cosa nel raggio di un chilometro e mezzo. Interi quartieri vennero vaporizzati; il ponte di ferro di Urakami fu fuso come cera. Le fiamme divorarono le strutture in legno, alimentate dal vento caldo che seguì all’onda d’urto.
Vittime e testimonianze
Si stima che circa 40.000 persone morirono all’istante. Nei giorni e nei mesi successivi, altre decine di migliaia persero la vita per le ferite, le ustioni e la sindrome acuta da radiazioni. Gli hibakusha, i sopravvissuti, raccontarono scene di un’irrealtà spaventosa: persone con la pelle che pendeva a brandelli, occhi ciechi e volti irriconoscibili; file di feriti che chiedevano acqua; corpi riversi lungo il fiume Urakami.
Molti dei soccorritori morirono a loro volta, colpiti dalle radiazioni mentre cercavano di salvare i superstiti. Gli ospedali, già scarsi di risorse dopo anni di guerra, furono rapidamente sopraffatti dall’afflusso di feriti e dalle patologie sconosciute che cominciavano a manifestarsi.
L’effetto strategico e la resa
Il 9 agosto stesso, mentre Nagasaki veniva colpita, l’Unione Sovietica lanciava un’offensiva su vasta scala in Manciuria. La combinazione di questi eventi — due bombe atomiche in tre giorni e l’ingresso in guerra dell’URSS — precipitò la crisi al vertice giapponese.
Sei giorni dopo, il 15 agosto 1945, l’imperatore Hirohito parlò per la prima volta direttamente alla nazione attraverso un messaggio radio, annunciando la resa incondizionata. Il Giappone accettava così le condizioni della Dichiarazione di Potsdam, ponendo fine alla guerra nel Pacifico e, di fatto, alla Seconda guerra mondiale.
Nagasaki rimase l’ultimo bersaglio di un attacco nucleare nella storia dell’umanità. Ma il prezzo pagato dalla città e dai suoi abitanti resta, a ottant’anni di distanza, una testimonianza diretta della capacità distruttiva della tecnologia atomica e delle decisioni politiche che la resero arma di guerra.