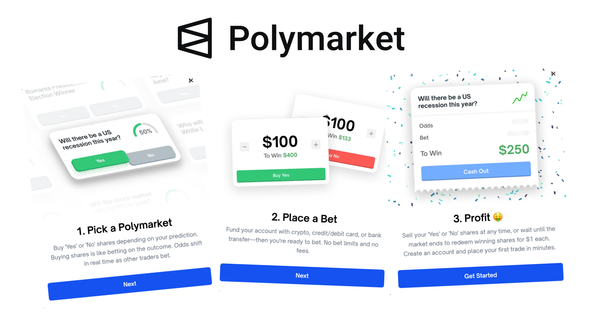Ma i Dem devono davvero diventare più moderati?
Un acceso dibattito negli Stati Uniti divide gli analisti: i candidati democratici moderati vincono più facilmente o conta di più altro? Il New York Times sostiene la prima tesi, ma diversi esperti contestano i dati e indicano problemi più profondi.

Dopo la sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2024, il Partito Democratico americano si interroga su cosa sia andato storto. La risposta che circola con maggiore insistenza è che i candidati troppo progressisti perdano voti, mentre quelli moderati vincano più facilmente. Ma è davvero così? Un dibattito acceso tra giornalisti, statistici e scienziati politici sta mettendo in discussione questa conclusione, rivelando errori di analisi e indicando problemi ben più complessi.
Al centro della controversia c'è un articolo pubblicato dal New York Times il 20 ottobre, in cui il comitato editoriale del giornale sostiene che i candidati democratici moderati per il Congresso abbiano ottenuto risultati significativamente migliori rispetto ai progressisti nelle elezioni del 2024. Secondo il Times, i moderati avrebbero superato la candidata presidenziale Kamala Harris di 2,8 punti percentuali nei loro distretti, mentre i non moderati sarebbero rimasti indietro di 1,2 punti. Una differenza totale di 4 punti che, secondo il giornale, dimostrerebbe il valore elettorale della moderazione.
La tesi del Times ha però scatenato molte critiche da parte di esperti di analisi statistica e politica. G. Elliott Morris, analista che gestisce la newsletter Strength In Numbers, ha dedicato due lunghi articoli a smontare l'argomento del giornale, evidenziando quello che definisce "errori statistici fondamentali". Morris non è solo: anche Adam Bonica, scienziato politico, e Andrew Gelman, noto statistico che ha studiato a lungo il tema della moderazione, hanno contestato l'analisi.
Il problema principale, secondo questi critici, è che il Times ignora altri fattori cruciali che spiegano le performance elettorali. In particolare, i candidati classificati come "moderati" erano in larga maggioranza candidati già in carica e avevano raccolto molti più fondi rispetto ai progressisti. "Il piccolo vantaggio elettorale che il Times attribuisce alla moderazione non è affatto una caratteristica dell'ideologia", scrive Bonica. "È un effetto fantasma creato ignorando le due forze più potenti nelle elezioni americane: la raccolta fondi e l'essere già in carica".
Quando si controlla statisticamente per questi fattori, il presunto vantaggio dei moderati si riduce da 4 punti a meno di un punto percentuale. In altre parole, quello che sembrava un chiaro beneficio della moderazione è in realtà l'effetto di candidati già affermati, con maggiori risorse economiche, che per caso risultano essere moderati. Morris aveva già analizzato i candidati democratici che persero seggi alla Camera nel 2020 per margini ridottissimi (meno di 2 punti): erano tutti moderati, più a destra rispetto al deputato democratico medio. Non persero perché non fossero abbastanza moderati, ma per altri problemi: un ambiente politico sfavorevole nelle aree rurali e suburbane, scarsa capacità di raccogliere fondi, scarso collegamento culturale con il distretto.
C'è poi un secondo problema metodologico. Il Times ha scelto una misura particolare per definire chi è "moderato": quali gruppi di pressione hanno sostenuto ciascun candidato. Ma secondo Bonica, se si usano praticamente tutte le altre misure standard di ideologia politica disponibili agli studiosi, l'effetto della moderazione risulta molto più piccolo o addirittura inesistente. Quando si misura l'ideologia basandosi su come gli elettori percepiscono i candidati, piuttosto che su quali gruppi li sostengono, si ottiene l'effetto più piccolo di tutti. "Il problema non è la complessità metodologica", osserva Bonica. "È che un'analisi rigorosa non riesce a mostrare il grande vantaggio della moderazione che l'editoriale descrive".
Il terzo errore riguarda il metro di paragone usato. Il Times confronta i risultati dei candidati al Congresso con quelli di Kamala Harris nel loro distretto. Ma Harris, come candidata presidenziale progressista, non rappresenta il candidato democratico "di ricambio" in un'elezione congressuale. Gli elettori democratici in Michigan o Louisiana non eleggerebbero mai un candidato progressista come Harris per un seggio alla Camera; nominerebbero qualcuno più vicino al centro. Confrontare i moderati con Harris, invece che con un ipotetico candidato democratico medio, gonfia artificialmente il vantaggio apparente della moderazione.
Morris ha costruito un modello statistico completo per testare questa ipotesi. Il risultato è che se si sostituisce un candidato progressita con uno che ha un'ideologia pari a quella del deputato democratico medio, la probabilità prevista di vittoria in una corsa equilibrata sale dal 46% al 51%. "Forse il Times non è d'accordo", commenta Morris, "ma non penso che un aumento del 5% nella probabilità di vittoria sia l'effetto che stanno vendendo nella loro analisi".
Andrew Gelman, professore di statistica alla Columbia University che già nel 2007 pubblicò uno studio sulla moderazione in politica, sostiene che le conclusioni di Morris siano coerenti con i suoi risultati di quasi vent'anni fa. "Nel nostro articolo stimammo che il beneficio medio della moderazione fosse circa il 2% dei voti", spiega Gelman. "Ma con l'aumento della polarizzazione politica ha senso che l'effetto elettorale di qualsiasi fattore sia in declino, quindi qualcosa più vicino all'1% sembra plausibile". Gelman aggiunge che ci sono prove che negli ultimi due decenni l'effetto dell'economia sulle elezioni presidenziali e il vantaggio derivante dall'essere già in carica nelle elezioni congressuali siano entrambi diminuiti.
Se la moderazione conta così poco, qual è allora il vero problema dei democratici? Secondo diversi analisti, la questione centrale è la "nazionalizzazione" delle elezioni. Lee Drutman, scienziato politico e ricercatore senior alla New America Foundation, ha pubblicato un'analisi che mostra come negli ultimi 25 anni la correlazione tra i risultati presidenziali e quelli del Senato e della Camera sia aumentata drasticamente. In altre parole, gli elettori sono diventati molto più propensi a votare per candidati del Congresso che appartengono allo stesso partito del loro candidato presidenziale preferito, rendendo sempre più raro il "voto incrociato" (quando qualcuno vota per un partito per il presidente e per l'altro partito per il Congresso).
"Stiamo litigando su come ottenere 1 punto percentuale in più da un elettorato", scrive Drutman, "diagnosticando queste piccole differenze come la grande storia della politica di oggi, quando la vera domanda per il partito è perché la differenza media tra i margini di voto per i candidati presidenziali e congressuali è diminuita dell'80% negli ultimi 25 anni". La grande sfida per i democratici nel Senato è come i candidati possano differenziarsi dal marchio nazionale del partito.
Questo fenomeno è particolarmente problematico per i democratici perché sono ormai diventati un partito urbano in un sistema con rappresentanza basata sulla geografia. Quando il marchio di partito si uniforma a livello nazionale, i candidati democratici nelle zone rurali (dove il Senato sovra-rappresenta gli elettori bianchi della classe lavoratrice) faticano a prendere le distanze dalle percezioni negative che gli elettori repubblicani hanno dei democratici delle grandi città. "Essere un 'democratico' dal Montana poteva significare qualcosa di diverso dall'essere un democratico da New York City" 60 anni fa, osserva Drutman. "Oggi non più".
Il problema non è principalmente ideologico. Drutman nota che la nazionalizzazione delle elezioni precede l'attuale conflitto ideologico nel Partito Democratico. Prima che Jon Tester del Montana e Sherrod Brown dell'Ohio perdessero nel 2024, c'erano stati Joe Donnelly dell'Indiana, Claire McCaskill del Missouri e Heidi Heitkamp del North Dakota che persero nel 2018, prima ancora che "woke" diventasse un termine nel dibattito politico. E nel 2012, Ben Nelson, il democratico più conservatore del Senato, decise di non ricandidarsi in Nebraska perché sapeva che non avrebbe vinto, nonostante le sue posizioni conservatrici. Anche con un curriculum di voto conservatore, non riuscì a superare la polarizzazione affettiva dei cittadini del Nebraska contro i democratici.
La dimostrazione più chiara che il problema non sia l'ideologia viene da un caso del 2024. Dan Osborn, candidato indipendente, arrivò a 5 punti dalla vittoria in Nebraska contro la repubblicana Deb Fischer, in uno Stato che votò per Trump con 20 punti di vantaggio. Osborn si presentò con un'agenda anti-establishment, pro-Trump e pro-muro al confine. Drutman è convinto che un democratico non si sarebbe mai avvicinato tanto alla vittoria, anche adottando le stesse identiche posizioni, semplicemente perché gli elettori repubblicani attribuiscono stereotipi negativi ai candidati democratici per via dell'etichetta di partito.
La soluzione che Drutman propone è il "fusion voting", un sistema elettorale che permette ai candidati di essere nominati da più partiti contemporaneamente. Un elettore potrebbe votare per un democratico moderato per il Congresso sotto l'etichetta di un ipotetico "Partito del Buon Senso" invece che del Partito Democratico. Questo sistema era comune negli Stati Uniti prima della guerra civile e sopravvive ancora nello Stato di New York. Permetterebbe ai candidati di differenziarsi dal marchio nazionale del loro partito senza dover rinunciare alle risorse e al supporto organizzativo che derivano dall'appartenenza a un partito maggiore. Negli Stati del Wisconsin, Kansas e New Jersey, piccoli gruppi di cittadini hanno formato nuovi partiti che vogliono usare il fusion voting per sostenere candidati moderati di entrambi gli schieramenti. "Anche con il sostegno di appena il 5% degli elettori per il candidato più moderato", spiega Drutman, "un'elezione che sarebbe stata una vittoria schiacciante di 10 punti diventa un pareggio. Questo cambia tutto nell'attuale competizione partitica al filo di lana".
Altri analisti contestano l'intera premessa del dibattito. Jonathan Bernstein, che scrive la newsletter Good Politics/Bad Politics, invita i democratici a "riprendersi" e smettere di auto-flagellarsi. Bernstein propone un "mantra" che i democratici dovrebbero ripetersi ogni mattina: hanno governato con successo tra il 2021 e il 2024, Harris e i democratici hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai partiti al governo in tutto il mondo nel 2024, Trump è impopolare e la maggior parte della sua agenda è impopolare. "I democratici probabilmente non hanno perso nel 2024 perché stavano fondamentalmente facendo cose sbagliate", scrive Bernstein. "Non c'è motivo di pensare che non vinceranno se le condizioni favoriranno il partito di opposizione nel 2026 e nel 2028".
Philip Bump, giornalista del Washington Post, sottolinea un altro aspetto: inseguire costantemente l'opinione pubblica con messaggi calcolati per piacere agli elettori ha contribuito a dare ai democratici la reputazione di essere opportunisti e insinceri. "Cosa succederebbe se invece i democratici si candidassero su ciò in cui credono, con termini che riflettono sinceramente quelle convinzioni?", si chiede Bump. "C'è ancora il problema dell'ambiente nazionale e del suo universo mediatico, ma adottando questo approccio i candidati possono almeno evitare meglio le accuse di essere semplicemente opportunisti o di usare retorica testata nei sondaggi. La sincerità può essere una posa, certo, ma è molto più facile apparire sinceri se lo sei davvero".
Un sondaggio del Pew Research Center condotto a settembre 2025 mostra che il problema è più ampio di quanto si pensi. Solo il 39% degli americani descrive il Partito Repubblicano come "governare in modo etico e onesto", e circa la stessa percentuale (42%) dice lo stesso del Partito Democratico. Maggioranze considerano entrambi i partiti "troppo estremi" nelle loro posizioni, anche se più persone applicano questo giudizio ai repubblicani (61%) rispetto ai democratici (57%). La frustrazione è alta in entrambi i partiti, ma è particolarmente elevata tra i democratici: il 67% dice che il proprio partito li fa sentire frustrati, molto più della metà circa che lo diceva nel 2021 e 2019. La ragione principale della frustrazione? Il 41% dei democratici frustrati dice che il partito "non ha reagito abbastanza duramente contro l'amministrazione Trump".
Il dibattito sulla moderazione, in definitiva, sembra concentrarsi su aggiustamenti marginali mentre forze molto più grandi stanno rimodellando la politica americana. La questione centrale non è se i candidati democratici debbano spostarsi di qualche punto percentuale verso il centro su singole questioni. Il problema vero è che gli elettori votano sempre più seguendo l'etichetta di partito nazionale, rendendo irrilevante quanto un candidato locale sia moderato o progressista. Se i democratici pensano di risolvere i loro problemi elettorali semplicemente moderando le posizioni su questo o quel tema, stanno sottovalutando la complessità della sfida che hanno davanti.