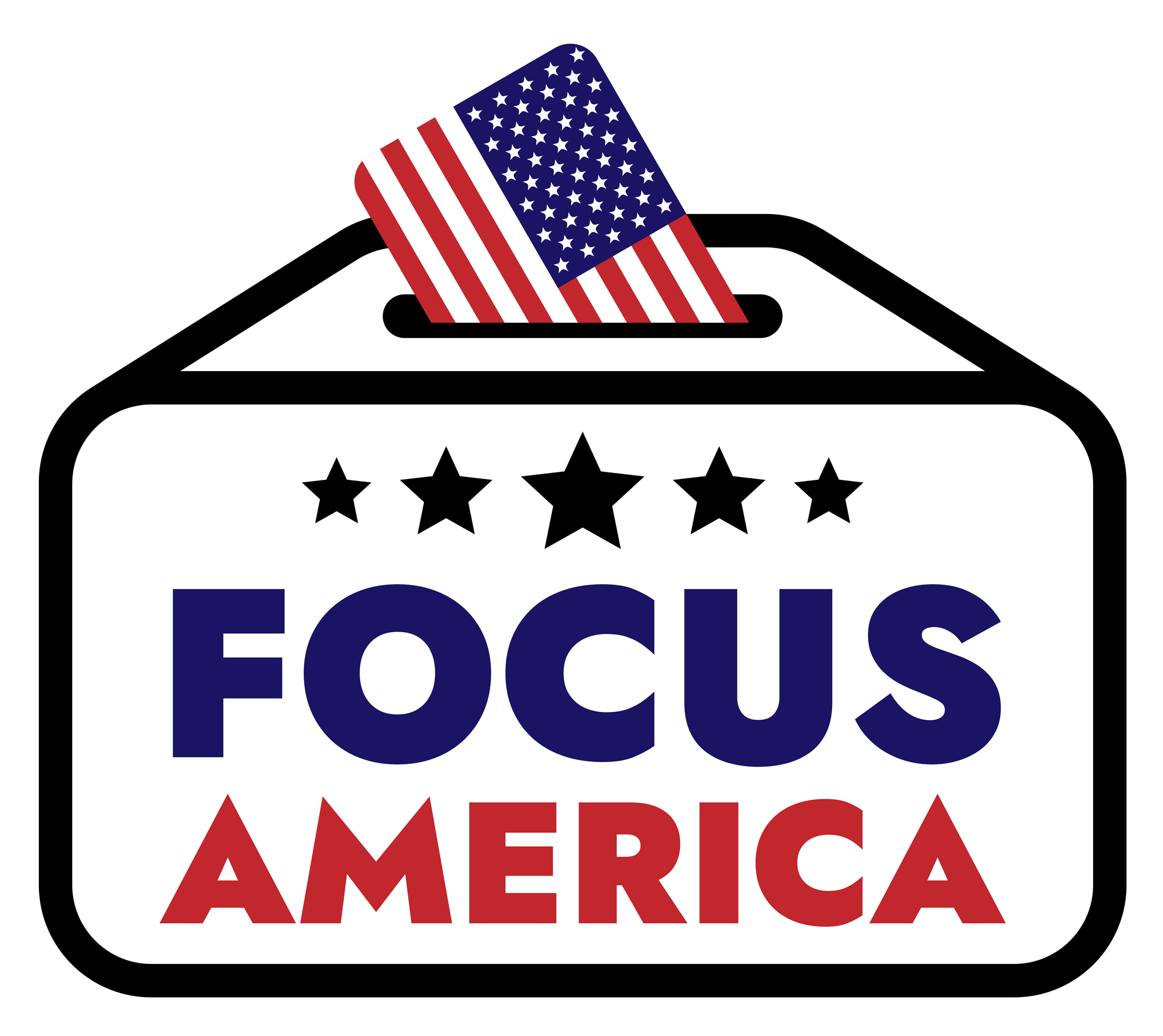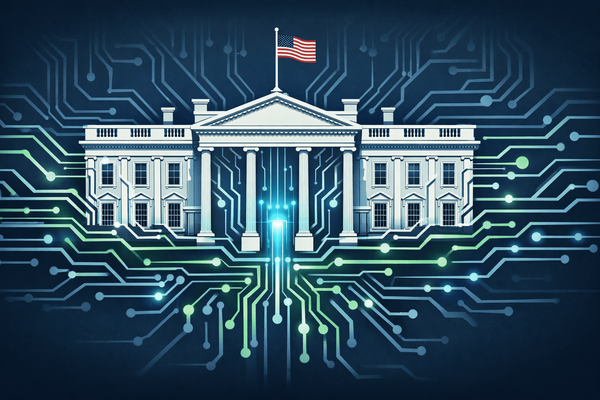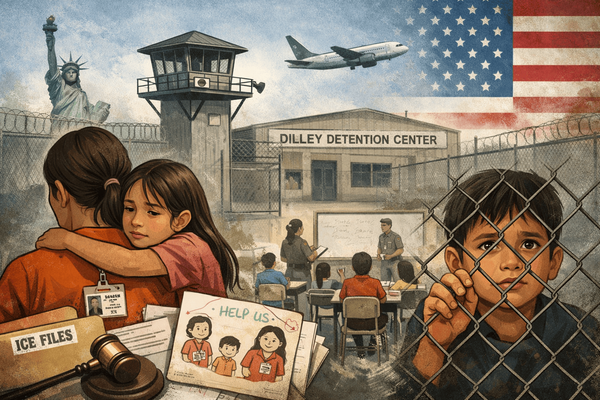L’accordo tra UE e Stati Uniti lascia aperti molti punti chiave
L’incontro tra Ursula von der Leyen e il presidente Donald Trump ha prodotto un’intesa sui dazi, ma restano numerose questioni da negoziare. I punti centrali riguardano le esportazioni europee verso gli Stati Uniti, le importazioni energetiche americane e i futuri investimenti europei.

Donald Trump ha ricevuto la delegazione europea nel suo resort di Turnberry, in Scozia, domenica 27 luglio, senza alcun documento scritto. Di fronte alla stampa, mentre annunciava il raggiungimento di un accordo commerciale, ha mostrato solo una pagina con poche annotazioni, poi ripiegata nella tasca della giacca. Nessun testo ufficiale è stato reso pubblico. Le informazioni disponibili arrivano da dichiarazioni orali dei due leader: la maggior parte delle esportazioni europee sarà tassata al 15%, con eccezioni ancora da definire. Parallelamente, l’Unione europea ha annunciato l’intenzione di acquistare grandi quantità di beni energetici statunitensi e di investire centinaia di miliardi di dollari negli Stati Uniti.
Questa modalità di negoziazione riflette lo stile abituale di Trump, che ha annunciato accordi con Regno Unito e Giappone senza tradurli in testi vincolanti. Anche la dichiarazione congiunta UE-USA, attesa entro il 1° agosto, non avrà carattere giuridico.
Le trattative non sono quindi concluse. Resta aperta, ad esempio, la definizione dei prodotti esentati dai dazi: Ursula von der Leyen ha citato genericamente «alcune sostanze chimiche», «alcuni farmaci generici» e «alcuni prodotti agricoli». Rimangono incognite sul futuro dei settori farmaceutico e dei semiconduttori, per ora esclusi da nuove tasse, ma suscettibili di revisione. A inizio luglio, Trump aveva persino minacciato dazi fino al 200% sui medicinali, creando forte incertezza tra le aziende europee.
Anche il comparto delle bevande alcoliche attende risposte: al momento i liquori sembrano avere maggiori possibilità di esenzione rispetto ai vini. Sull’acciaio e l’alluminio restano in vigore le attuali sovrattasse del 50%, con future negoziazioni necessarie per stabilire quote di esportazione.
Un nodo significativo riguarda l’impegno europeo ad acquistare prodotti energetici statunitensi per 750 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, principalmente gas naturale liquefatto, petrolio e combustibili nucleari. Secondo la Commissione europea, si tratta di una stima basata sulla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento, riducendo la dipendenza dalla Russia. Tuttavia, gli esperti dubitano della fattibilità: nel 2024 le importazioni di energia dagli Stati Uniti ammontavano a circa 70 miliardi di dollari. Per raggiungere i 750 miliardi, i volumi dovrebbero più che triplicare ogni anno, un obiettivo che gli stessi Stati Uniti non sembrano in grado di garantire a causa delle limitate infrastrutture portuali.
In parallelo, l’UE prevede di aumentare di 600 miliardi di euro gli investimenti nell’economia statunitense. Anche in questo caso si tratta di proiezioni, non di obblighi vincolanti, come ha ammesso la stessa Commissione europea.
Sul piano politico, restano molte incognite. Quali saranno le reazioni di Trump se le promesse annunciate a Turnberry non si concretizzeranno? Il presidente può attuare rapidamente modifiche commerciali tramite executive orders, mentre la Commissione deve scegliere tra una procedura snella, ma limitata, e un accordo internazionale più complesso. In ogni caso, servirà la maggioranza qualificata degli Stati membri: 55% dei Paesi rappresentanti almeno il 65% della popolazione UE. La posizione di Stati influenti come Francia o Germania sarà dunque decisiva.
L’accordo di Turnberry, ancora privo di testo definitivo, rappresenta un punto di partenza ma lascia irrisolte molte questioni cruciali, dalla lista precisa dei prodotti esentati dai dazi fino alla reale portata degli investimenti e delle importazioni energetiche.