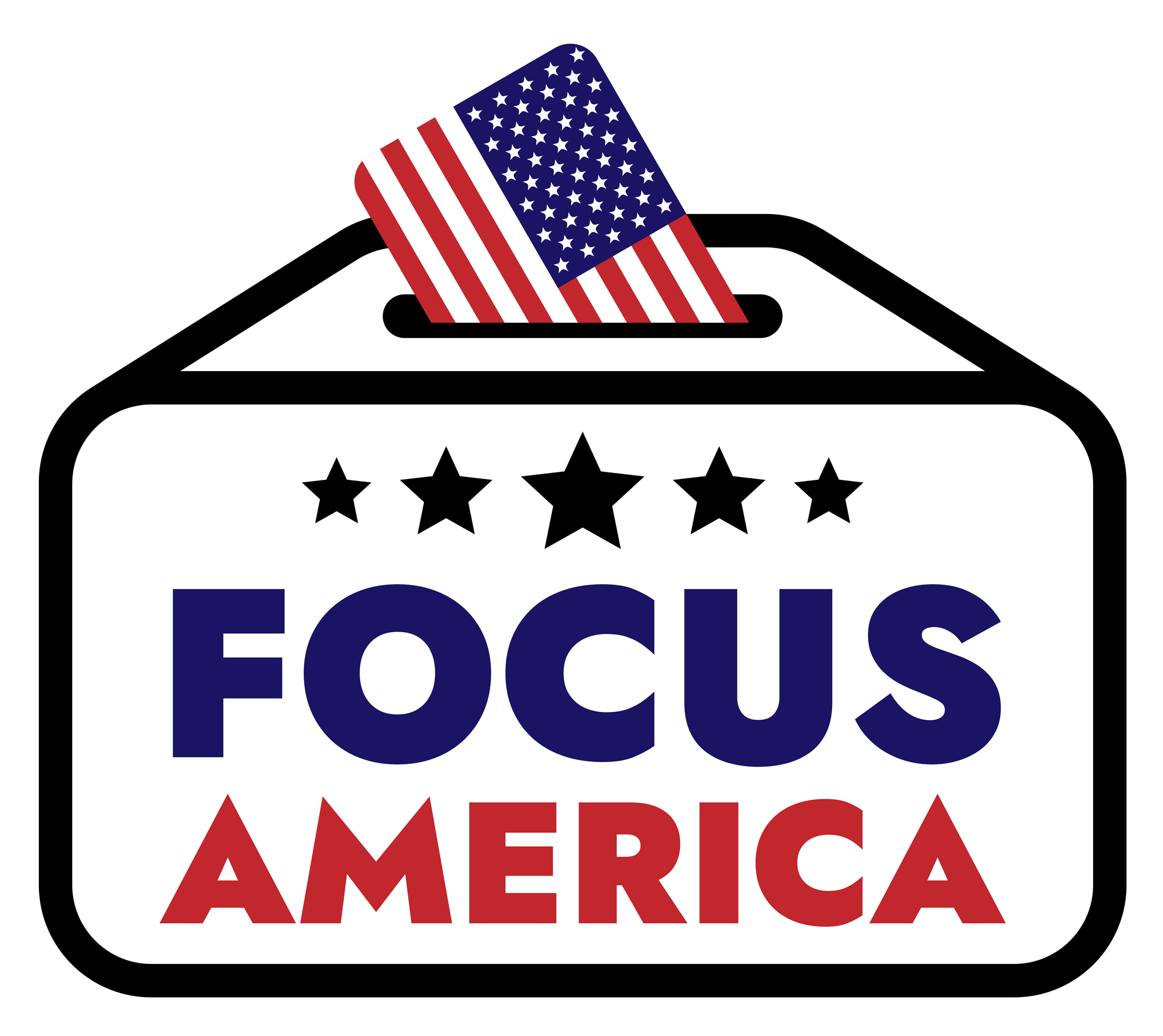La fine degli aiuti americani sta avendo un impatto devastante in Africa
Il presidente Donald Trump ha smantellato l’Usaid, riducendo dell’83% i programmi e chiudendo l’agenzia. L’impatto è devastante per l’Africa, dove molti paesi dipendevano dall’assistenza americana per sanità, istruzione e crisi umanitarie.

Il presidente Donald Trump dal primo giorno ha avviato una drastica revisione dell’assistenza internazionale, con conseguenze devastanti per l’Africa. Lo smantellamento dell’Usaid – l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale creata nel 1961 – e la cancellazione dell’83% dei programmi hanno lasciato milioni di persone senza sostegno in settori cruciali come la sanità, l’istruzione e la sicurezza alimentare.
Il 20 gennaio, appena tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato, Trump ha sospeso l’aiuto americano, definendo “sprechi” i miliardi di dollari destinati alla cooperazione. Nonostante le proteste di governi e organizzazioni internazionali, il 10 marzo Washington ha confermato la chiusura dell’agenzia senza attendere la revisione di 90 giorni inizialmente prevista. Il 1° luglio l’Usaid ha ufficialmente cessato le attività. Il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato che, a suo avviso, l’agenzia non ha raggiunto risultati significativi dalla fine della guerra fredda e che l’Africa si è dimostrata “poco riconoscente” verso la generosità americana.
Secondo i dati citati da Rubio, dal 1991 il continente africano ha ricevuto 165 miliardi di dollari di aiuti statunitensi, ma ha sostenuto la posizione di Washington solo nel 29% delle risoluzioni votate all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo indicatore, interpretato come una misura della “gratitudine” politica, riflette la visione transazionale di Trump nelle relazioni internazionali, anche con i paesi più poveri.
La nuova linea della Casa Bianca privilegia il commercio e gli investimenti privati rispetto all’assistenza pubblica. Secondo l’amministrazione, lo sviluppo e la riduzione della povertà dipenderanno meno dai finanziamenti statali e più dalla capacità dei paesi di attrarre capitali e imprese, in particolare statunitensi. Nonostante l’obiettivo internazionale di destinare lo 0,7% del PIL all’aiuto pubblico, gli Stati Uniti hanno sempre investito molto meno, fermandosi allo 0,25%. Con la riforma voluta da Trump, i fondi saranno concessi solo a “nazioni capaci di aiutarsi da sole” e con programmi mirati, a tempo limitato.
Le conseguenze di questa scelta sono gravi, soprattutto in Africa, dove l’Usaid garantiva in media un terzo dell’assistenza internazionale. Sei paesi – Etiopia, Sud Sudan, Nigeria, Uganda, Kenya e Repubblica Democratica del Congo – figuravano tra i dieci maggiori destinatari dei finanziamenti statunitensi. La chiusura dell’agenzia ha colpito non solo i programmi bilaterali, ma anche le agenzie delle Nazioni Unite, che hanno perso in media il 25% dei loro fondi, con picchi ancora più alti per alcune di esse.
Il Programma alimentare mondiale (PAM) ha già ridotto le operazioni in Mauritania, Mali e Repubblica Centrafricana. Senza nuovi fondi, le scorte di cibo per i sette paesi dell’Africa occidentale in cui opera si esauriranno entro settembre. La situazione è critica anche sul fronte sanitario: mancano medicinali essenziali per malattie come il paludismo, e i programmi di prevenzione e trattamento dell’HIV sono fortemente rallentati. Solo una parte dei finanziamenti per il Pepfar – il programma globale contro l’AIDS lanciato nel 2003 dal presidente George W. Bush – è stata salvata il 18 luglio grazie a un intervento del Congresso.
Anche le politiche di salute materna e infantile hanno subito un duro colpo, con interruzioni nei servizi di assistenza e vaccinazione. Nei campi profughi e nelle comunità colpite da conflitti interni, la carenza di aiuti rischia di aggravare le condizioni di migliaia di rifugiati e sfollati.
Alcuni leader africani, come il presidente keniota William Ruto e lo zambiano Hakainde Hichilema, hanno interpretato questa crisi come un’occasione per riflettere sulla necessità di maggiore autonomia nello sviluppo economico. Ma la realtà sul terreno resta drammatica: gestire l’impatto immediato del ritiro statunitense è una sfida urgente per governi e organizzazioni umanitarie.