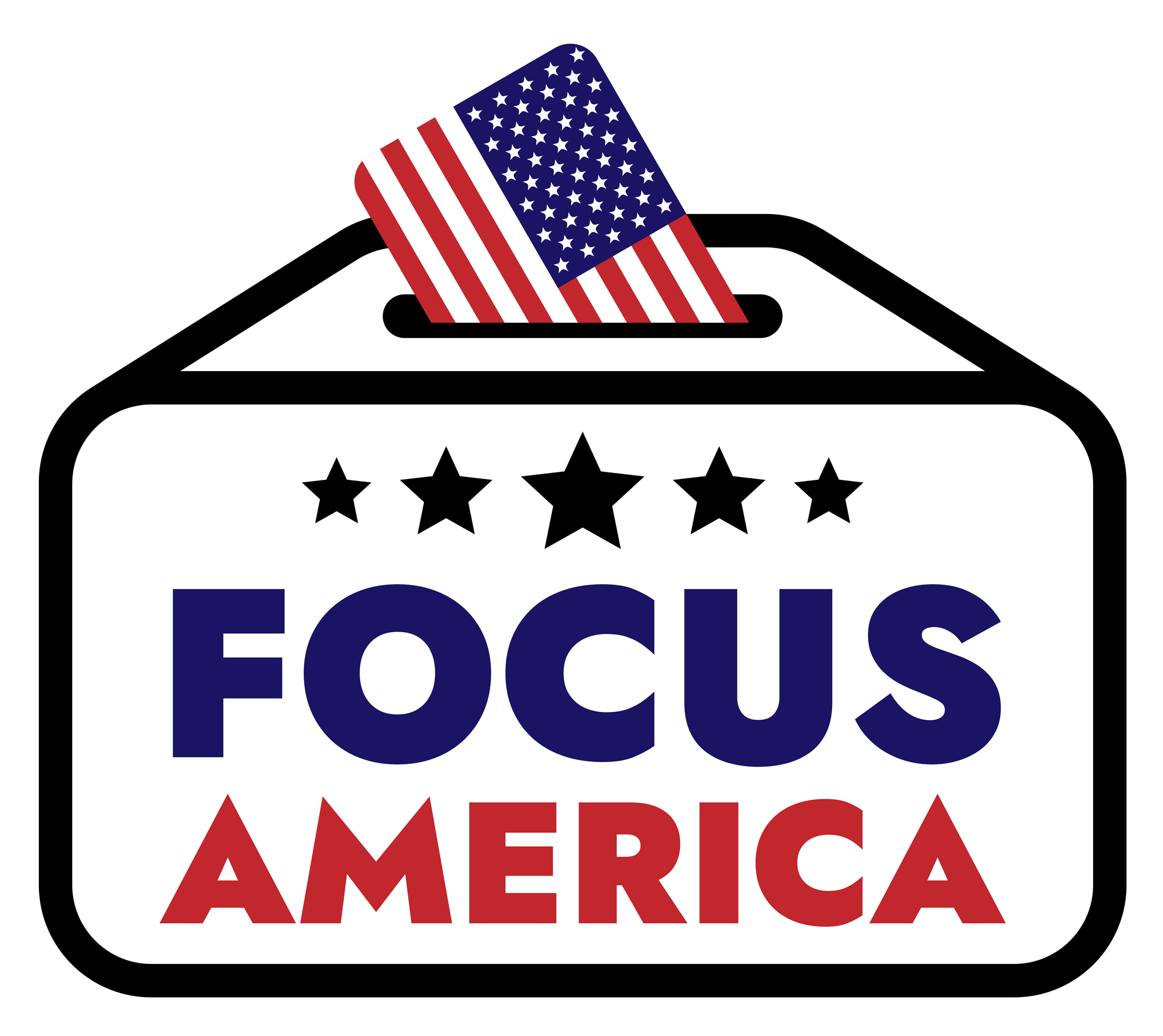In che modo Trump ha trasformato il deficit commerciale in dazi contro i partner esteri
Un'analisi del Financial Times rivela come l'Amministrazione Trump abbia usato una formula che trasforma matematicamente il deficit commerciale in aliquote tariffarie che arrivano fino al 49%.

Un articolo del Financial Times ha rivelato la formula con cui l’Amministrazione Trump ha calcolato i nuovi dazi doganali “reciproci”, suscitando reazioni a dir poco contrastanti da parte degli analisti economici e dei leader internazionali.
La linea ufficiale, presentata dallo stesso presidente Trump, è stata comunicata con estrema semplicità: “Reciproco significa che loro lo fanno a noi, e noi lo facciamo a loro. È molto semplice, non può essere più semplice di così”.
Tuttavia, la pubblicazione della lista dettagliata dei dazi per ciascun Paese ha mostrato che dietro questa semplicità apparente si cela una metodologia decisamente meno trasparente, basata su un calcolo matematico che ha lasciato perplessi molti esperti.
Una formula aritmetica applicata al deficit commerciale
Secondo il Financial Times, la Casa Bianca ha, infatti, adottato un calcolo che si basa direttamente sul deficit commerciale bilaterale tra gli Stati Uniti e ciascun paese. In pratica:
- Si prende il valore del deficit commerciale (quanto gli USA importano in più rispetto a quanto esportano) con un determinato Paese.
- Si divide per il totale delle importazioni da quel Paese.
- Il risultato, espresso in percentuale, viene dimezzato: questa è l’aliquota del dazio “reciproco” applicata a quel Paese.
Esempio: se gli Stati Uniti importano 100 dollari di beni da un paese ma ne esportano solo 40, il deficit è di 60 dollari. Dividendo 60 per 100 si ottiene il 60%. Il dazio applicato sarà quindi del 30%.
Il caso Bangladesh
Un caso emblematico analizzato dal Financial Times riguarda il Bangladesh. Gli Stati Uniti, nel 2024, hanno importato beni per un totale di 8,4 miliardi di dollari dal Paese asiatico, registrando un deficit commerciale di 6,2 miliardi.
Dividendo il deficit per le importazioni totali si ottiene un valore del 73,8%, che dimezzato produce un dazio del 36,9%.
Ma, durante il suo annuncio, Trump ha parlato di un dazio “imposto” del 74%, attribuendolo al Bangladesh, citando genericamente “manipolazione valutaria e barriere commerciali” — in realtà, una trasposizione diretta della percentuale di squilibrio, leggermente arrotondata, e non una misura realmente adottata da Dacca.
Secondo il FT, la formula è stata verificata su 24 paesi, con differenze minime dovute solo ad arrotondamenti. Fonti della Casa Bianca hanno confermato la metodologia, spiegando che Trump ha voluto "essere indulgente" dimezzando l’aliquota per "essere gentile con il resto del mondo".
Una logica economica alternativa
Dal punto di vista teorico, la giustificazione dell’Amministrazione Trump poggia su una critica radicale ai modelli classici del commercio internazionale.
Secondo l’Ufficio del Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti (USTR), i dazi “reciproci” servono a compensare gli squilibri persistenti nei conti commerciali bilaterali, squilibri che – si legge nei documenti ufficiali – non si correggono automaticamente nel tempo, come invece vorrebbero molte teorie economiche.
La Casa Bianca sostiene che i deficit duraturi siano il risultato di una combinazione di ostacoli tariffari e non tariffari: normative ambientali troppo restrittive, aliquote fiscali sbilanciate, costi di conformità elevati, manipolazione valutaria e altre forme di sottovalutazione monetaria.
Tutti fattori che, secondo Trump, hanno contribuito a deviare la domanda interna americana verso mercati esteri, causando dal 1997 la chiusura di oltre 90.000 fabbriche e la perdita di più di 6,6 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero.
Il modello economico “ufficiale” utilizzato
A sostegno di questa linea, il sito dell’USTR espone anche un modello economico più complesso rispetto alla formula aritmetica rilevata dal Financial Times.
Questo modello include parametri come l’elasticità della domanda, la distribuzione dell’effetto dei dazi sui prezzi al consumo e altre variabili di equilibrio.
Per le simulazioni, sono stati utilizzati i dati aggiornati del 2024, con l’elasticità fissata a 4 — un valore considerato conservativo, poiché studi recenti suggeriscono che nel lungo periodo essa si aggiri intorno a 2.
Impatto economico e reazioni dei mercati
Nel frattempo, l’impatto della nuova politica doganale inizia subito a farsi sentire.
Secondo il Budget Lab di Yale, i dazi annunciati ieri hanno fatto salire l’aliquota tariffaria media effettiva degli Stati Uniti di 11,5 punti percentuali, raggiungendo il 22,5% — il livello più alto dal 1909.
I mercati hanno reagito con preoccupazione: i futures dell’S&P 500 hanno registrato un calo del 2,7%, mentre quelli del Nasdaq sono scesi del 3,4% nella serata di ieri.
Le basi legali e le critiche degli economisti
Per sostenere legalmente la misura, l’Amministrazione Trump ha incluso tutte le autorità giuridiche disponibili nel nuovo ordine esecutivo, facendo ricorso all’International Emergency Economic Powers Act, al National Emergencies Act, e alle sezioni 604 e 301 del Trade Act del 1974.
Il Financial Times osserva come questo approccio sembri fondarsi sull’idea che ogni deficit commerciale sia, per definizione, il frutto di pratiche sleali o manipolazione valutaria, trascurando il principio fondamentale del vantaggio comparativo, introdotto da David Ricardo.
Questo principio suggerisce che ogni Paese dovrebbe specializzarsi nella produzione di ciò che sa fare meglio, anche se ciò comporta deficit commerciali temporanei.
La metodologia della Casa Bianca appare particolarmente discutibile in casi come quello delle banane o del caffè, prodotti che gli Stati Uniti semplicemente non possono coltivare in grandi quantità per ragioni climatiche e che, inevitabilmente, alimentano deficit commerciali con i Paesi esportatori.
Come scrive ironicamente la giornalista Alexandra Scaggs:
“È preoccupante… Cosa dire delle banane? Semplicemente non crescono in molte parti degli Stati Uniti!”
Ad ogni modo, comunque la si voglia vedere, la nuova politica tariffaria rappresenta un cambio di paradigma radicale nell’approccio americano al commercio globale, con potenziali conseguenze profonde sulle relazioni internazionali e sull’economia interna.
Se da un lato l’obiettivo dichiarato è la tutela della produzione e dell’occupazione negli Stati Uniti, dall’altro il metodo scelto solleva leciti interrogativi fondamentali sulla comprensione e sull’applicazione dei principi economici di base da parte dell’attuale Amministrazione.