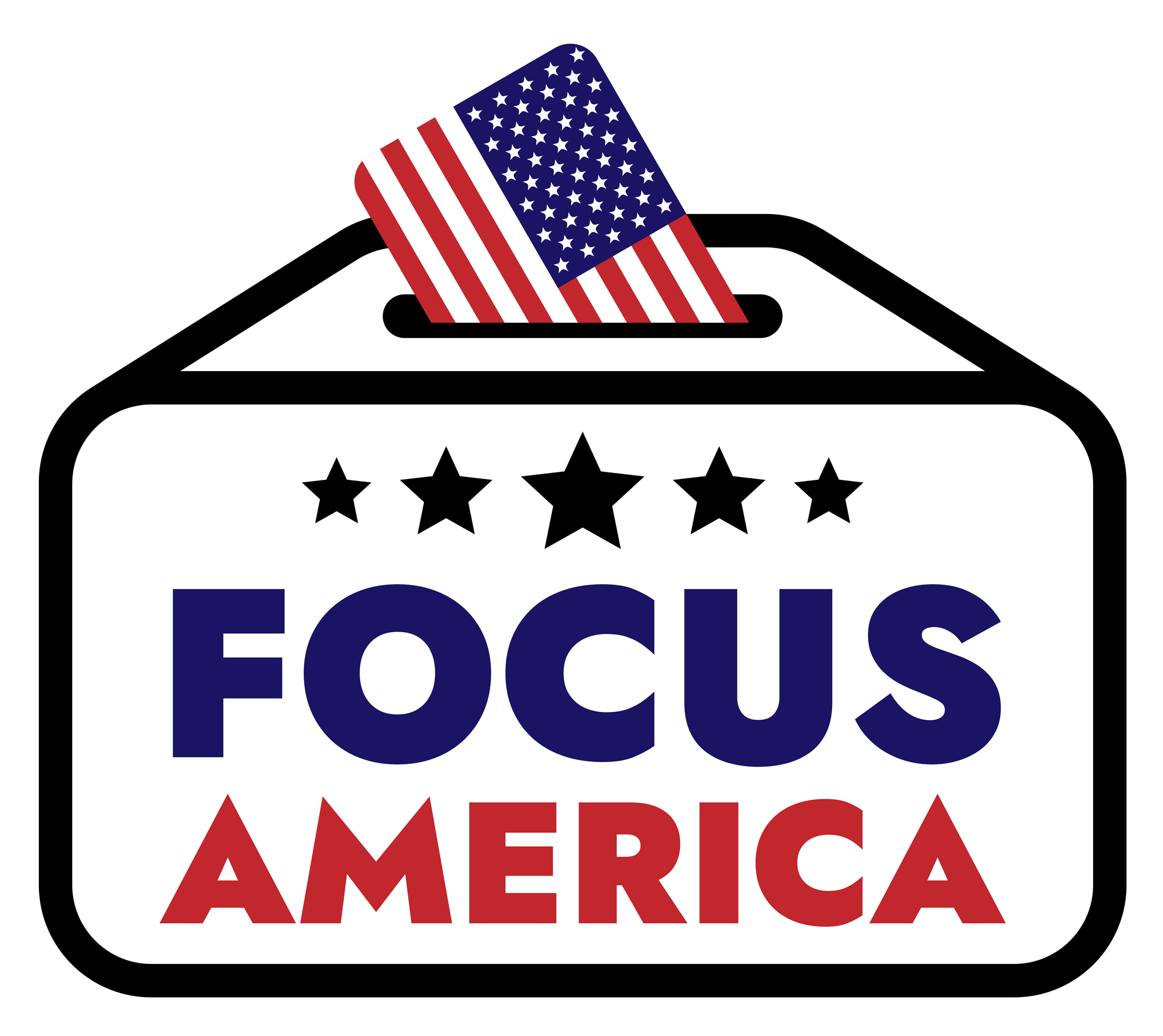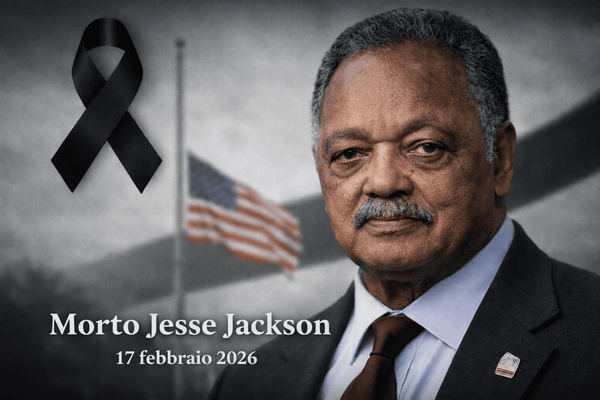I primi 100 giorni di Trump: America First torna al centro della politica estera
Nei primi 100 giorni del suo secondo mandato, Donald Trump ha rilanciato un'agenda muscolare: pace in Ucraina a costo di concessioni da parte di Kyiv, crisi umanitaria a Gaza, negoziati sul nucleare iraniano e progetti espansionistici che scuotono l’ordine internazionale.
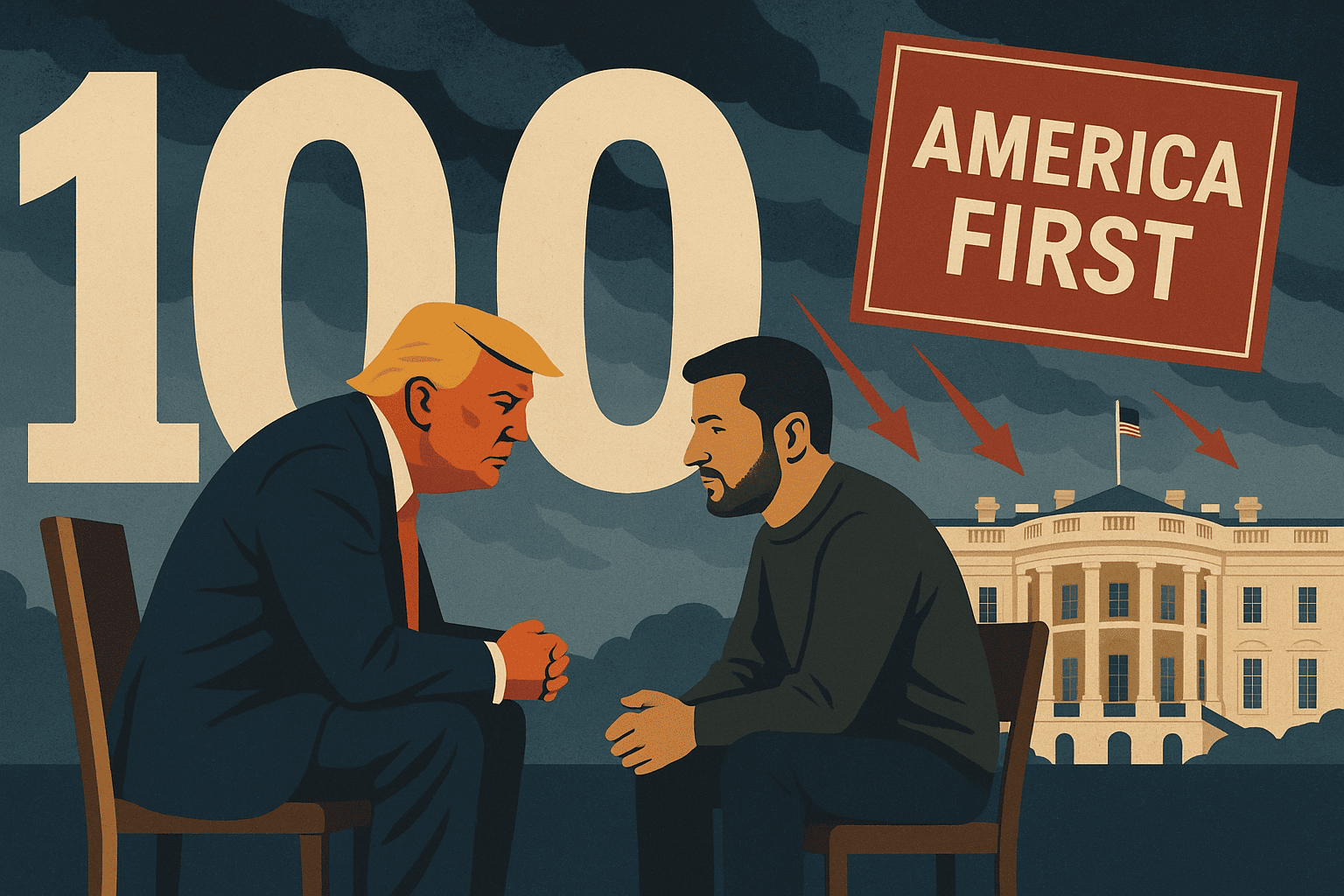
Dal 20 gennaio Donald Trump è tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato presidenziale. Nei primi cento giorni la sua Amministrazione ha preso decisioni controverse e senza precedenti, mettendo subito alla prova la propria stabilità. Fin dalle prime ore è apparso evidente che lo stile non sarebbe cambiato rispetto al primo quadriennio, anzi tutto il contrario: linguaggio muscolare, annunci su social prima dei canali istituzionali e un’agenda-shock in cui politica interna ed estera si intrecciano senza soluzione di continuità.
Il conflitto russo-ucraino: una pace ai danni dell’Ucraina?
Tornato alla Casa Bianca, Donald Trump ha tentato di riavviare il dialogo fra le parti in guerra, fermo da oltre due anni, esercitando una doppia pressione: la minaccia di sospendere gli aiuti militari a Kyiv e, specularmente, di potenziarli per fare pressione su Mosca. L’assenza della delegazione ucraina ai colloqui preliminari di Jeddah tra emissari statunitensi e russi ha però incrinato subito i rapporti tra Kyiv e Washington.
La Casa Bianca ha successivamente subordinato la prosecuzione dell’assistenza militare a un “ritorno economico”, vale a dire l'accesso preferenziale per le imprese USA alle risorse minerarie ucraine. Pur tra forti tensioni, le due parti avevano definito un testo di accordo condiviso sui minerali rari, ma la firma è saltata dopo il burrascoso incontro nello Studio Ovale fra Trump e Volodymyr Zelensky del 28 febbraio 2025, che ha compromesso profondamente la relazione bilaterale.

A seguito di quell’episodio gli Stati Uniti hanno congelato per qualche giorno gli aiuti militari e la condivisione d’intelligence, riattivandoli solo quando Kyiv ha accettato un cessate il fuoco di 30 giorni: la Federazione Russa, però, non lo ha ancora sottoscritto formalmente, limitandosi per ora a tregue di 48-72 ore.
Nonostante le frizioni, i rapporti Trump-Zelensky si sono gradualmente ricomposti, fino al simbolico faccia a faccia nella Basilica di San Pietro in occasione dei funerali di papa Francesco il 26 aprile 2025.
Restano tuttavia aperti diversi interrogativi sugli obiettivi del presidente russo Vladimir Putin, che potrebbe sfruttare ogni nuova tensione tra Washington e Kyiv per consolidare i propri vantaggi territoriali, soprattutto dopo la presentazione del piano di pace statunitense che prevede, tra l’altro, il riconoscimento formale della cessione della Crimea alla Russia e quello de facto delle zone attualmente occupate nelle altre regioni ucraine.
Occorre ricordare, a questo proposito, che il diritto internazionale — richiamato, tra l’altro, dalla Risoluzione ES-11/4 dell’Assemblea Generale dell’ONU — vieta l’acquisizione di territorio con la forza in assenza di un motivo legittimo. Le giustificazioni addotte da Mosca per l’annessione dei territori ucraini illegalmente occupati si sono rivelate infondate, configurando una palese violazione di tali norme.

In questo contesto, accettare la cessione della Crimea e degli altri territori occupati, come prevede la bozza di piano di pace statunitense sottoposta a Kyiv e ai partner europei, equivarrebbe ad aprire un pericoloso “vaso di Pandora”: si rischierebbe infatti di erodere l’intero impianto giuridico che regola i confini internazionali e di legittimare la conquista armata, la stessa logica che portò ai conflitti mondiali del Novecento.
Rimane, infine, nebulosa la natura delle garanzie di sicurezza che Washington sarebbe disposta a offrire all’Ucraina una volta concluso il conflitto per scoraggiare una futura nuova aggressione russa: a oggi non è stato prodotto alcun documento vincolante e, sebbene si discuta di una possibile missione di peacekeeping guidata dai Paesi europei con il sostegno statunitense, per Kyiv la questione resta imprescindibile da chiudere prima di qualsiasi concessione.
Niente passi avanti sul conflitto a Gaza
La guerra tra Israele e Hamas resta estremamente complessa e priva di soluzioni rapide. Concedere legittimità a Hamas – organizzazione designata terrorista da Stati Uniti e Unione europea – e ripristinare lo status quo antecedente al 7 ottobre 2023 sarebbe politicamente impraticabile; al tempo stesso, l’Amministrazione Trump ha sempre più problemi ad impegnarsi a contenere le frange più oltranziste del governo israeliano ed a coinvolgere i Paesi arabi vicini nella definizione di un percorso condiviso per il futuro della Striscia.
Nel suo primo mandato (2017-2021) Donald Trump aveva presentato il piano Peace to Prosperity (gennaio 2020), percepito come squilibrato a favore di Israele e respinto dalla leadership palestinese. Tornato alla Casa Bianca, il presidente ha finora ottenuto solo un cessate il fuoco temporaneo, che però si è concluso a marzo, senza ottenere progressi negoziali di lungo periodo. La perdurante percezione di una scarsa attenzione alle esigenze palestinesi continua ad ostacolare la mediazione americana.
Anche una vittoria esclusivamente militare di Israele a Gaza appare però poco plausibile. Malgrado l’impiego di oltre 25.000 tonnellate di munizioni nei primi venticinque giorni di guerra e le successive operazioni di terra, le Forze di Difesa israeliane non sono riuscite a neutralizzare l’intera infrastruttura bellica di Hamas né a liberare tutti gli ostaggi restanti: la rete di circa 500 km di tunnel sotterranei e la struttura di comando decentrata continuano a garantire al movimento islamista capacità di combattimento e resilienza logistico-politica.
Il prezzo umanitario, al contrario, cresce giorno dopo giorno. Secondo i dati OCHA/OMS aggiornati a febbraio 2025, nella Striscia si registrano oltre 48.000 vittime palestinesi, 1,7 milioni di sfollati e il 92 % delle abitazioni risulta gravemente danneggiato o distrutto. In tale contesto, la prosecuzione delle ostilità rischia di aggravare ulteriormente la crisi senza avvicinare una soluzione politica.
Finora, le iniziative dell’Amministrazione Trump non hanno prodotto svolte significative. Mentre si negozia un evanescente cessate il fuoco di lunga durata, la diplomazia rimane impantanata. Nel frattempo, l’offensiva militare — pur infliggendo danni rilevanti a Hamas — non è riuscita a disarticolarne del tutto l’apparato operativo e ha spinto la popolazione civile verso una catastrofe umanitaria, lasciando entrambe le parti senza un percorso credibile verso la pace.

Iran: un nuovo accordo sul nucleare è davvero possibile?
La Repubblica Islamica dell’Iran si trova oggi indubbiamente in fase di declino nello scacchiere mediorientale. Il colpo più duro è arrivato l’8 dicembre 2024, quando i ribelli siriani hanno conquistato Damasco, costringendo l'ex dittatore Bashar al-Assad alla fuga a Mosca e privando così Teheran del suo alleato chiave nella regione.
Già alcuni mesi prima, però, un altro alleato chiave dell'Iran, Hezbollah, era uscito profondamente indebolito dal confronto con Israele, mentre prima ancora il riavvicinamento diplomatico con l’Arabia Saudita — formalizzato a Pechino il 10 marzo 2023 — aveva rimodellato gli equilibri regionali, restringendo i margini di manovra dell’Iran, che tuttavia continua a esercitare un’influenza tutt’altro che trascurabile in Iraq e nello Yemen.
Sul fronte interno, gli effetti delle sanzioni internazionali si fanno sentire con forza: a marzo 2025 il rial ha segnato il minimo storico di 1.039.000 per dollaro, mentre l’inflazione annua si aggira ormai da anni intorno al 40%. L’erosione del potere d’acquisto alimenta un crescente malcontento sociale, riducendo ulteriormente i margini di manovra economica del governo.
Al centro di queste dinamiche c’è l’accordo sul nucleare (JCPOA) del 2015, già compromesso dal ritiro unilaterale degli Stati Uniti annunciato da Donald Trump l’8 maggio 2018, accompagnato dall'introduzione di sanzioni di “massima pressione”. Rientrato alla Casa Bianca, Trump ha rilanciato la stessa strategia: il 6 febbraio 2025 Washington ha varato un nuovo pacchetto di misure, seguito da ulteriori designazioni del Dipartimento di Stato e del Tesoro volte a ridurre a zero le esportazioni petrolifere iraniane.
In parallelo, gli Stati Uniti — con il sostegno del Regno Unito — hanno avviato una campagna di bombardamenti contro le milizie Houthi nello Yemen, intensificatasi fra marzo e aprile 2025. Pur senza colpire direttamente l’Iran, l’operazione mira anche a logorare i suoi alleati regionali.
In questo contesto, sul piano diplomatico, i negoziati per un nuovo accordo sul nucleare hanno ripreso vigore: dopo un primo incontro in Oman, un secondo round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran si è svolto a Roma il 19 aprile 2025. Al termine, Teheran ha proposto di incontrare i tre Paesi europei firmatari del JCPOA (i cosiddetti Paesi E3) nella capitale italiana il 2 maggio 2025, come tappa preparatoria ad altri colloqui con Washington.
Restano però vaghi i contorni di una possibile intesa. Gli Stati Uniti, per bocca del Segretario di Stato Marco Rubio, insistono sulla cessazione totale dell’arricchimento di uranio in Iran; Teheran considera la richiesta irricevibile e pretende in cambio la revoca graduale delle sanzioni. Arrivare a un compromesso si preannuncia, dunque, molto arduo, ma la speranza di Washington è che la combinazione di isolamento politico, pressioni economiche e perdita di leve strategiche potrebbe spingere la leadership iraniana, oggi più fragile, a riesaminare costi e benefici con maggiore pragmatismo.
Le mire espansionistiche di Trump
Rientrato alla Casa Bianca, Trump ha trasformato la farsesca retorica espansionistica del primo mandato in una vera e propria agenda di governo. Nei primi cento giorni ha evocato l’acquisizione di territori “naturalmente legati” agli Stati Uniti: l’acquisto (o la conquista) della Groenlandia, l’annessione del Canada e la riappropriazione del Canale di Panama. Secondo la Casa Bianca, l’obiettivo sarebbe creare un corridoio strategico nord-sud capace di garantire al continente "sicurezza energetica e militare".
Già nel 2019 Trump aveva ipotizzato di comprare la Groenlandia. Ma quella che allora sembrava una boutade è ora tornata sul tavolo, al punto da ventilare perfino un intervento armato contro un Paese membro della NATO. In risposta, il re di Danimarca, in visita a Nuuk, ha riaffermato l’unità del Regno, mentre il neo-premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha bollato l’offerta come "irrispettosa" della volontà dei cittadini groenlandesi. L’idea resta talmente impopolare negli Stati Uniti che, al Congresso, persino molti repubblicani frenano.
Parallelamente, la storica disputa commerciale con il Canada si è trasformata in pressione territoriale. Su Truth Social Trump ha più volte evocato l’annessione del vicino settentrionale come rimedio ai "sussidi al Canada" e ai dazi sull’acciaio: "Il confine è artificiale, l’unione era destino fin dall’inizio", ha scritto alla vigilia delle elezioni federali canadesi. La sortita ha compattato tutti i partiti di Ottawa e, sull’onda del nazionalismo, ha favorito la vittoria dei Liberali di Mark Carney, dati inizialmente per spacciati dai sondaggi.
Il Canada, reame del Commonwealth che riconosce re Carlo III, vede ora nella monarchia un baluardo costituzionale; da Londra arrivano però soltanto attestati di solidarietà misurata, mentre il sovrano evita toni diretti per non incrinare i rapporti con Washington.
Non meno controversa è la posizione assunta nei confronti di Panama. Il 26 aprile 2025 Trump ha incaricato il Segretario di Stato Marco Rubio di negoziare il passaggio gratuito di navi statunitensi nel Canale, ricordando che gli USA "potrebbero sempre riprendere il controllo" dell’opera inaugurata nel 1914 e ceduta definitivamente nel 1999. Panama ha definito la minaccia "irricevibile" e contraria ai trattati Carter-Torrijos del 1979.
Se quest’agenda espansionistica fosse attuata integralmente, rischierebbe di intaccare i cardini stessi della sicurezza occidentale — dall’Articolo 5 della NATO al principio di autodeterminazione, fino alla neutralità del Canale di Panama — offrendo al contempo nuove opportunità di penetrazione a Russia e Cina nell’Artico e in America Latina. Molti analisti continuano a descrivere tali uscite come tattica negoziale d’urto; ciononostante, la loro reiterazione accresce le tensioni, scoraggia gli investimenti e obbliga gli alleati a pronunciarsi su questioni finora impensabili, alimentando un’ulteriore fonte di instabilità nello scenario internazionale.