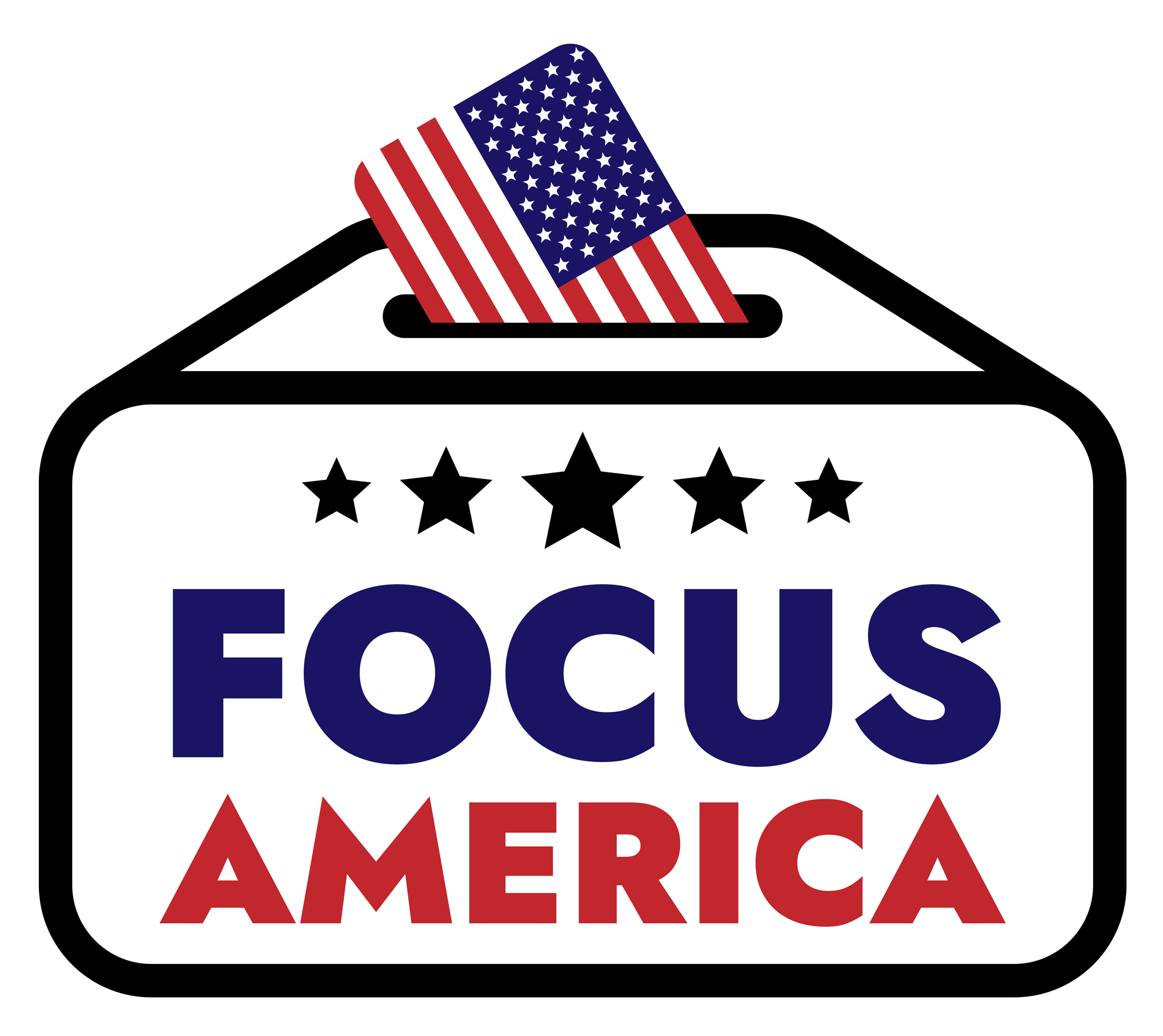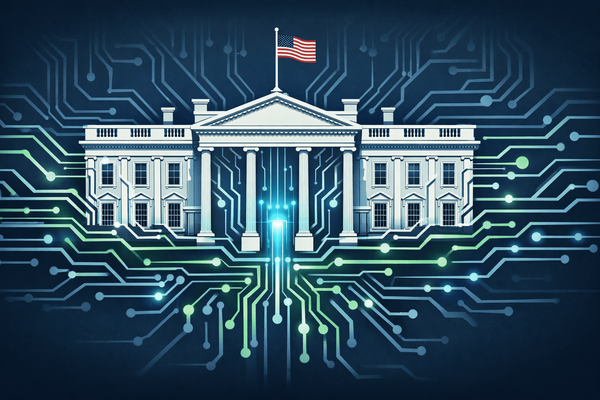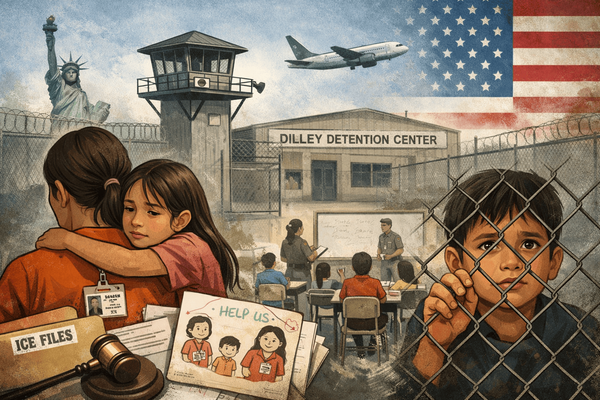Entrano in vigore i nuovi dazi: gli Stati Uniti archiviano il libero scambio
Da oggi entra in vigore il nuovo regime tariffario voluto dal presidente americano: la tassa media sulle importazioni sale dal 2% al 17,3%. Colpite 69 nazioni, inclusa l’Unione Europea. Accordi e sanzioni modellano un ordine commerciale globale dominato da logiche politiche.

I nuovi dazi doganali imposti dal presidente Donald Trump sono entrati in vigore giovedì 7 agosto, alle 00:01 ora di Washington, le 6:01 in Europa. Con questo atto, gli Stati Uniti hanno rotto ufficialmente con oltre cinquant’anni di libero scambio, alzando il dazio medio sulle importazioni di beni dal 2% registrato a gennaio al 17,3% attuale, secondo i dati del Budget Lab dell’università di Yale. È il livello più alto dagli anni Trenta, quando il protezionismo dominava la politica commerciale americana.
Il provvedimento, più volte annunciato e rinviato, coinvolge 69 paesi, inclusi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Per la maggior parte, il nuovo dazio si attesta al 15%. Tuttavia, alcune nazioni sono colpite in misura maggiore: tra queste l’Algeria, la Bosnia-Erzegovina, la Libia, il Sudafrica (30%), l’Iraq e la Serbia (35%). Ancora più penalizzanti sono le misure applicate a titolo di ritorsione.
L’India, ad esempio, subisce un aumento del 25% a causa dei suoi acquisti di petrolio russo. Il Brasile si vede imporre dazi del 50% su determinati beni per via delle indagini giudiziarie in corso contro l’ex presidente Jair Bolsonaro, alleato di Trump. Il Canada paga il 35% per aver tentato di reagire con contromisure, mentre il Regno Unito – primo a firmare un accordo con Washington – ottiene un trattamento di favore (10%). Per il Messico, le trattative sono state rinviate di 90 giorni, mentre resta incerta la posizione della Cina, con cui le trattative sono ancora in corso.
Tre elementi chiave emergono da questa svolta protezionista. Il primo è l’imprevedibilità. A poche ore dall’entrata in vigore dei dazi, Trump ha annunciato una tassa del 100% sui semiconduttori importati, a meno che le imprese non costruiscano impianti produttivi negli Stati Uniti. La misura, pur drastica, ha permesso di esentare Apple, che lo stesso giorno ha promesso 100 miliardi di dollari di investimenti nel paese, così come TSMC, il colosso taiwanese dei semiconduttori.
Il secondo elemento riguarda la negoziabilità delle misure. Il caso della Svizzera è emblematico: colpita da dazi del 39%, ben più alti rispetto ai suoi vicini europei, la Confederazione ha tentato un’ultima mediazione attraverso la visita della presidente Karin Keller-Sutter a Washington. L’incontro con il segretario di Stato Marco Rubio, tuttavia, non ha prodotto risultati concreti.
A questo si aggiunge l’assenza di trasparenza. I dettagli degli accordi e delle esenzioni non sono stati pubblicati e rimangono oggetto di negoziati intensi. L’intesa con l’Unione Europea, ad esempio, presenta ancora numerose incognite su prodotti chiave come acciaio, alluminio, vini e superalcolici.
Il terzo elemento è di natura politica. I dazi si rivelano un potente strumento di pressione più che una misura economica. Molti paesi, invece di rispondere con misure equivalenti, hanno scelto la via del compromesso, promettendo investimenti negli Stati Uniti. È il caso dell’UE, che ha annunciato 600 miliardi di euro di investimenti e 750 miliardi di acquisti energetici nei prossimi tre anni. Una concessione simbolica che Donald Trump ha rivendicato come vittoria.
Dal punto di vista economico, però, i risultati sono più sfumati. Gli esperti mettono in guardia sugli effetti collaterali per i consumatori americani. Jason Furman, docente ad Harvard ed ex consigliere economico di Barack Obama, ha spiegato in un intervento sul Financial Times che i dazi finiranno per ridurre i benefici derivanti dalle importazioni e per frenare anche le esportazioni. Ha inoltre sottolineato che definire “vincitori” e “perdenti” in ambito commerciale è fuorviante: gli Stati Uniti hanno sì aumentato il gettito doganale, ma a spese del potere d’acquisto dei propri cittadini.
Gli indicatori macroeconomici offrono segnali contraddittori. Il tasso di disoccupazione resta basso, ma il rapporto sul mercato del lavoro pubblicato a luglio – che ha provocato il licenziamento della direttrice del Bureau of Labor Statistics – segnala un rallentamento nella creazione di nuovi impieghi da tre mesi consecutivi. La crescita economica sembra reggere, trainata soprattutto dagli investimenti nell’intelligenza artificiale. L’inflazione, pur contenuta, mostra segnali di ripresa, mentre la contrazione del disavanzo commerciale registrata a giugno appare legata soprattutto all’accumulo preventivo di scorte da parte degli importatori.
In un’intervista al Wall Street Journal, Austan Goolsbee, presidente della Federal Reserve di Chicago, ha ricordato che i beni importati rappresentano “solo” l’11% del PIL americano. L’effetto complessivo dei dazi potrebbe dunque restare limitato, a patto di evitare tre scenari: una controffensiva dei paesi colpiti (per ora scongiurata), un impatto sulle forniture industriali (oggetto dei negoziati in corso), e un calo della fiducia da parte dei consumatori e dei mercati.
La nuova era commerciale inaugurata dal presidente Trump si fonda su scelte bilaterali, trattative opache e un uso esplicito del commercio come leva di potere geopolitico. Resta da vedere se, nel medio periodo, questa strategia porterà alla reindustrializzazione promessa o se finirà per ricadere su chi la sostiene: i cittadini e le imprese statunitensi.