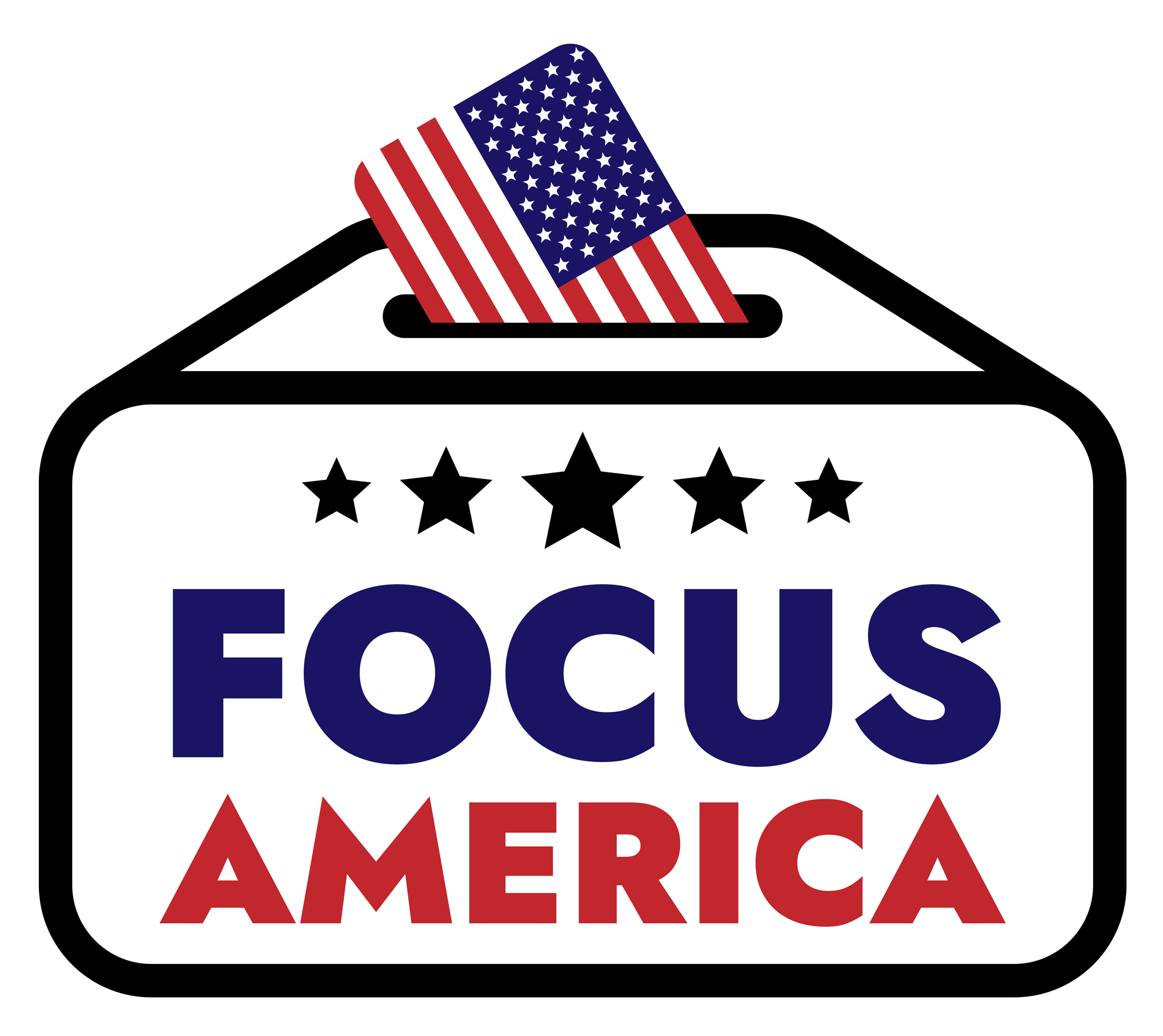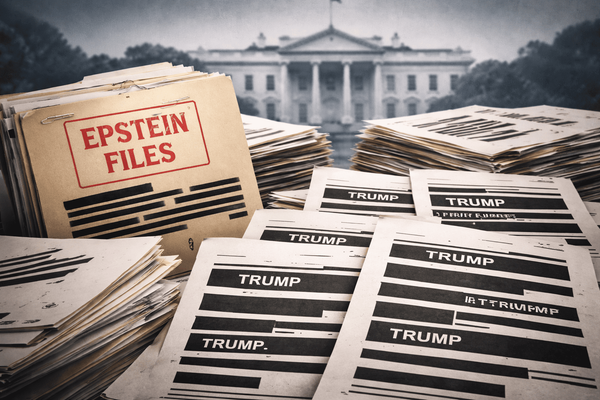Hiroshima, il punto di non ritorno
Ottant’anni dopo la prima bomba atomica, Hiroshima resta il simbolo del potere distruttivo della scienza e dell’urgenza di una riflessione etica sul futuro dell’umanità.

Il 6 agosto 1945, alle 8:15 del mattino, un bombardiere statunitense B-29 chiamato Enola Gay sganciò sulla città giapponese di Hiroshima una bomba atomica al plutonio, soprannominata Little Boy. Fu il primo impiego bellico di un’arma nucleare nella storia dell’umanità. In pochi secondi, una città intera fu trasformata in rovina: decine di migliaia di persone morirono all’istante, molte altre nei giorni, mesi e anni successivi. A ottant’anni esatti da quell’evento, Hiroshima continua a interrogare le coscienze e a sollevare domande che toccano il cuore della modernità: sulla guerra, sulla scienza, sul potere e sulla responsabilità morale.
La decisione di sganciare la bomba
Nel luglio 1945, quando la bomba era pronta, la Germania nazista era già stata sconfitta. Restava il Giappone, che continuava a combattere nonostante l’evidente inferiorità militare. L’amministrazione Truman si trovava di fronte a una scelta: invadere il Giappone con una massiccia operazione terrestre, che avrebbe potuto costare centinaia di migliaia di vite statunitensi, oppure ricorrere alla nuova arma segreta sviluppata con il Progetto Manhattan. Il 26 luglio, con la Dichiarazione di Potsdam, gli Alleati intimarono al Giappone la resa incondizionata, senza fare menzione esplicita della bomba atomica. Il governo giapponese rifiutò. Dieci giorni dopo, Hiroshima venne scelta come obiettivo primario.
La scelta dell’impiego atomico fu dettata da una combinazione di fattori militari, politici e simbolici. Oltre all’obiettivo di forzare la resa giapponese, vi era anche la volontà di mostrare al mondo – e in particolare all’Unione Sovietica – il potere della nuova tecnologia americana. La bomba, insomma, non era solo uno strumento bellico, ma anche un segnale geopolitico in un mondo che stava entrando rapidamente nella Guerra fredda.
Una città annientata
Prima del bombardamento, Hiroshima era una città con circa 350.000 abitanti. Era un centro industriale, logistico e militare, ma anche un agglomerato urbano densamente popolato. Quando la bomba esplose, a circa 600 metri d’altezza sopra il centro cittadino, sprigionò una potenza equivalente a 15.000 tonnellate di tritolo. L’onda d’urto distrusse quasi tutti gli edifici nel raggio di due chilometri. La temperatura al suolo raggiunse i 4.000 gradi Celsius. Si stima che tra le 70.000 e le 80.000 persone morirono sul colpo; altre 70.000 morirono nei mesi successivi a causa delle ustioni, delle ferite e soprattutto delle radiazioni.
Hibakusha – così sono chiamati in Giappone i sopravvissuti alla bomba – raccontarono scene di distruzione assoluta: corpi carbonizzati, persone che camminavano come fantasmi con la pelle pendente dalle braccia, una città trasformata in un paesaggio lunare. Molti morirono nei giorni seguenti per l’“infermità atomica”, una condizione all’epoca sconosciuta: i medici non sapevano come trattare gli effetti delle radiazioni. Nei decenni successivi, aumentò l’incidenza di leucemie, tumori e malformazioni congenite tra i sopravvissuti e i loro discendenti.
L’eredità morale e politica
Il bombardamento di Hiroshima – seguito tre giorni dopo da quello su Nagasaki – è stato giustificato dagli Stati Uniti come un atto necessario a porre fine rapidamente alla guerra e a salvare vite umane. Molti storici, tuttavia, hanno messo in dubbio questa narrazione. Alcuni sostengono che il Giappone fosse già sull’orlo della resa, e che l’entrata in guerra dell’Unione Sovietica contro il Giappone (annunciata l’8 agosto) sarebbe bastata a chiudere il conflitto. Altri vedono nell’uso della bomba un esperimento in tempo reale, motivato dalla volontà di affermare la supremazia americana nel mondo postbellico.
Il dibattito storico resta aperto, ma al di là della controversia sulle intenzioni, l’effetto simbolico della bomba fu devastante. Per la prima volta nella storia, l’umanità sperimentava la possibilità concreta della propria autodistruzione. Le immagini di Hiroshima entrarono nell’immaginario collettivo come monito: la scienza, senza una guida etica, può generare mostri.
Hiroshima oggi
A Hiroshima, ogni 6 agosto si tiene una cerimonia al Parco della Pace, dove sorge il Memoriale della bomba atomica, l’unico edificio parzialmente sopravvissuto alla deflagrazione. La città, oggi moderna e ricostruita, è diventata un simbolo globale del pacifismo e della lotta per il disarmo nucleare. Le testimonianze degli hibakusha, raccolte in centinaia di libri, film e musei, continuano a parlare alle nuove generazioni.
Eppure, il rischio nucleare non è affatto scomparso. Oggi nel mondo esistono circa 12.500 testate nucleari, in possesso di nove paesi. Il Trattato di non proliferazione, in vigore dal 1970, ha contribuito a frenare la corsa agli armamenti, ma le tensioni geopolitiche degli ultimi anni – dalla guerra in Ucraina alle minacce tra Stati Uniti, Cina e Iran – hanno riportato il tema al centro dell’attenzione. La dottrina della “mutua distruzione assicurata” continua a regolare l’equilibrio del terrore, ma non offre alcuna garanzia contro errori umani, escalation improvvise o atti terroristici.
Un monito per il futuro
Hiroshima non è solo un evento storico: è una soglia, un punto di non ritorno per la civiltà. È l’esempio più estremo della capacità umana di distruggere e della necessità di scegliere responsabilmente cosa fare con il proprio potere. A ottant’anni da quel giorno, ricordare Hiroshima non significa solo commemorare le vittime, ma interrogarsi su come costruire un mondo in cui una simile tragedia non possa mai più ripetersi.