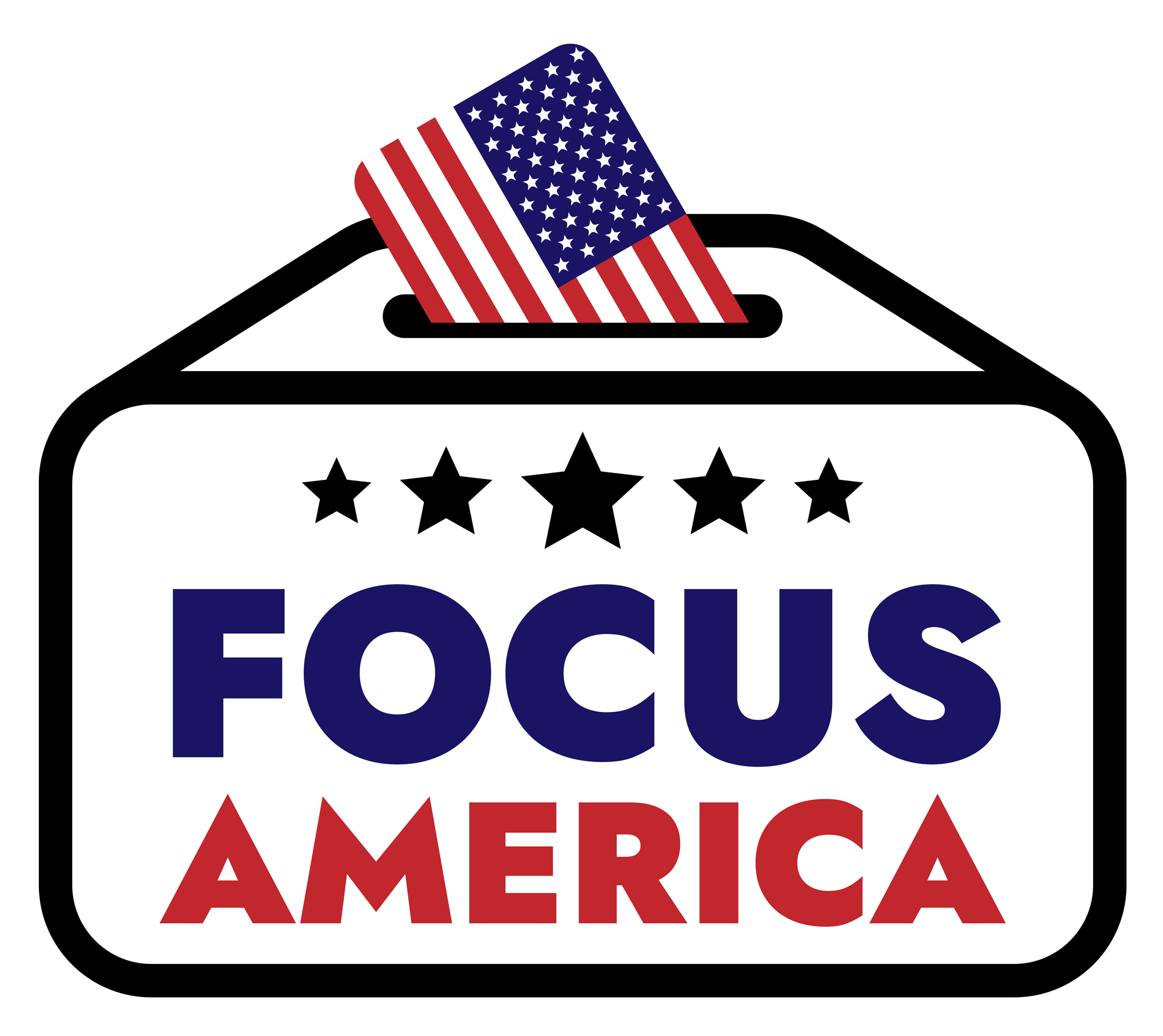Divergenze tra Trump e Putin sul percorso verso la pace in Ucraina
Le proposte americane si scontrano con le ambizioni massimaliste russe: Mosca non intende rinunciare a condizioni viste da Washington come inaccettabili.
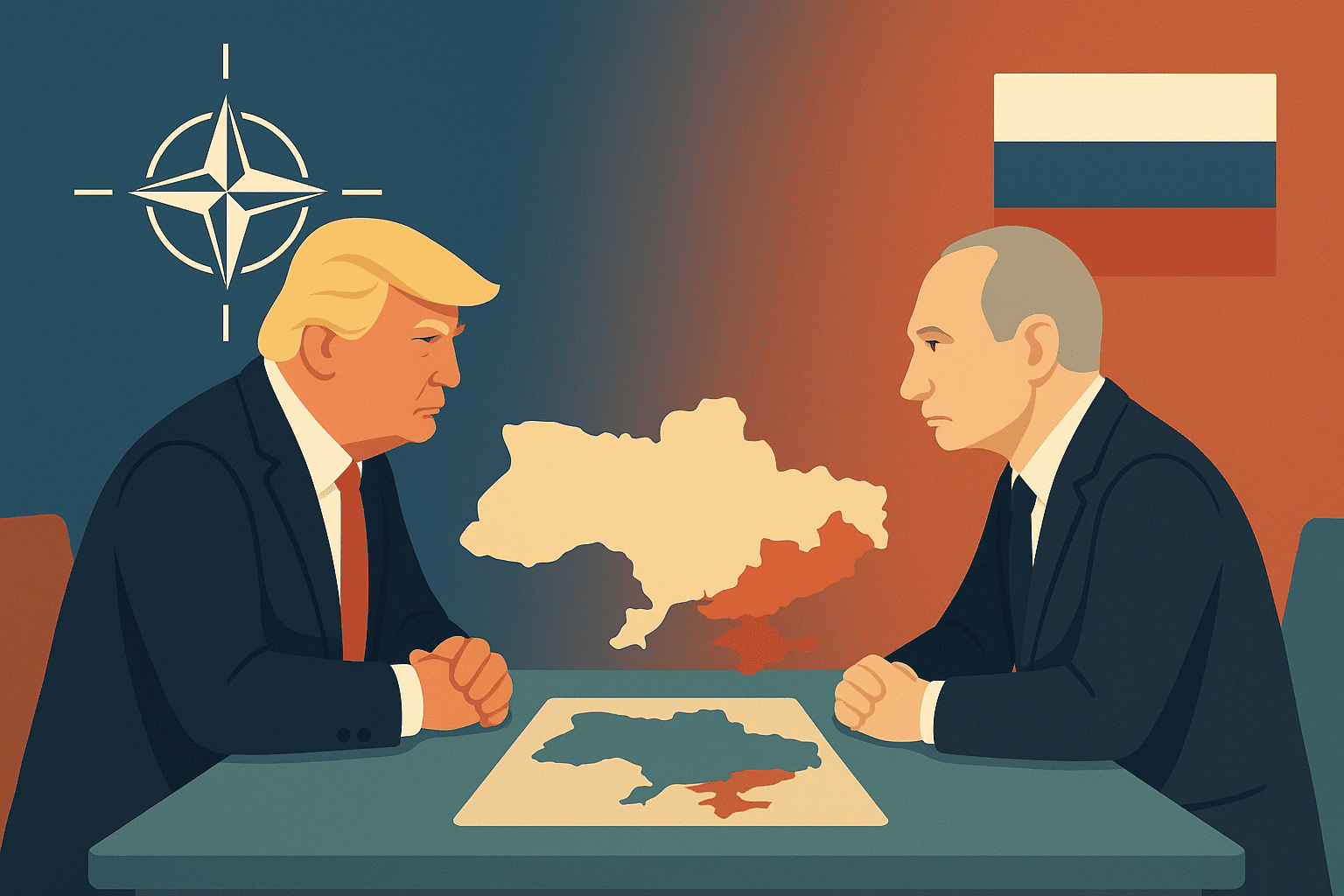
Il presidente Donald Trump ha promesso, prima in campagna elettorale e poi una volta tornato alla Casa Bianca una rapida soluzione al conflitto in Ucraina, basandosi però su una visione semplificata delle cause della guerra. La sua proposta si fonda sull'assunto che la guerra sia stata provocata principalmente dalla prospettiva di adesione ucraina alla NATO.
In quest’ottica, Trump ha pensato che fosse sufficiente chiudere ufficialmente la porta dell'Alleanza Atlantica all’Ucraina per eliminare la motivazione principale dell’aggressione russa. Tuttavia, dopo oltre cento giorni alla Casa Bianca, l'Amministrazione Trump si è trovata di fronte a richieste russe ben più estese e complesse rispetto alle proprie aspettative iniziali.
L'allargamento delle richieste russe
Mosca insiste, infatti, su una più ampia "eliminazione delle cause primarie" del conflitto, che può essere di volta in volta interpretata in maniera estesa da vari portavoce russi come denazificazione, smilitarizzazione dell'Ucraina, cambio di regime e riconoscimento delle acquisizioni territoriali stabilite secondo la Costituzione russa aggiornata.
Tali richieste superano di molto ciò che Washington aveva inizialmente previsto. Trump, da parte sua, si è dimostrato già disposto a compiere passi significativi per venire incontro alla Russia, inclusi il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea e sul fronte attualmente occupato, la revoca delle sanzioni, la normalizzazione delle relazioni diplomatiche e commerciali, e il reintegro di Mosca nella comunità internazionale.
L'Amministrazione americana ritiene, infatti, che tale apertura potrebbe spingere Putin a rinunciare definitivamente all’uso ulteriore della forza. Tuttavia, per Mosca queste offerte rappresentano solo un punto di partenza minimo, non sufficiente per accettare una pace durevole.
Il divario tra aspettative americane e ambizioni russe
Se per Trump le sue concessioni appaiono generose, dal punto di vista del Cremlino rappresentano, infatti, il minimo necessario per considerare una trattativa. La Russia infatti non è disposta a rinunciare ad ambizioni molto più ampie, simili a quelle contenute negli ultimatum all'Occidente del 2021 e ribadite negli obiettivi dichiarati all'inizio della cosiddetta "operazione speciale" nel 2022.
In quei “ultimatum” Mosca chiedeva anzitutto la garanzia che l’Alleanza non si sarebbe mai più espansa verso Est, ma anche il ritiro degli armamenti occidentali da alcuni Paesi confinanti con la Federazione Russa, nonché l’impegno formale a escludere qualsiasi intervento militare o dispiegamento di forze straniere in quelle aree.
All’inizio del 2022, con il lancio di quella che viene definita “operazione speciale”, le stesse istanze si sono tradotte in obiettivi concreti: la “denazificazione” – ovvero la modifica del quadro politico ucraino – e la “smilitarizzazione” del Paese, intesa come riduzione drastica o eliminazione delle capacità difensive ucraine. piano militare ma anche su quello legislativo e culturale.
Queste ambizioni, più radicali e pervasivi di quanto previsto dalla proposta americana, riflettono la convinzione del Cremlino che una pace “vera” debba comprendere non soltanto la fine delle ostilità, ma anche un ridisegno profondo dell’assetto istituzionale e territoriale ucraino, così da assicurare alla Russia un’influenza diretta e duratura sul suo vicino.
A ciò si aggiunge l'aspirazione di Mosca a influenzare politicamente e culturalmente l’Ucraina dall’interno, con richieste che riguardano non solo la sicurezza, ma anche aspetti legislativi, linguistici, storici ed elettorali. Queste divergenze rendono estremamente complicato per Washington convincere la controparte russa ad accettare condizioni che non prevedano la soddisfazione di tutte le sue richieste.
Parallelamente, dopo tre anni di conflitto, la società russa è sempre più militarizzata e indottrinata in una retorica bellicista che rende complicato per Putin giustificare una pace basata su compromessi limitati. L’immagine del conflitto come lotta contro un "nazismo risorto" limita fortemente il margine di manovra politica e retorica del Cremlino.
Presentare un risultato parziale come una vittoria decisiva risulta difficile, dato che dopo anni di combattimenti la Russia controlla territori la cui legittimità internazionale è ampiamente contestata, composti in buona parte di zone rurali o piccole città ormai rase al suolo ed in gran parte inabitabili ed ha fallito la conquista di obiettivi simbolici rilevanti come la conquista di Kharkiv e Odesa.
La ricerca di una "nuova Yalta"
Mosca guarda, quindi, con favore a una soluzione che rievoca la conferenza di Yalta del 1945, ovvero un grande accordo diplomatico tra grandi potenze per legittimare i risultati ottenuti sul campo. Tale scenario è visto dal Cremlino come la migliore via d’uscita dal conflitto, se Trump fosse disposto a sostenere questa opzione purché ciò comporti la fine delle ostilità.
Nonostante ciò, la stessa storia di Yalta rivela l’intrinseca instabilità di simili accordi. Gli accordi presi allora non evitarono l'inizio della Guerra Fredda, né impedirono ulteriori conflitti globali. Oggi Putin si trova di fronte a una simile scelta: cercare una legittimazione internazionale dei propri obiettivi o continuare a basarsi sulla forza militare per mantenere le conquiste già ottenute.
Nonostante l’apertura degli Stati Uniti guidati da Trump, la pace in Ucraina appare perciò ancora lontana, ostacolata da una distanza considerevole tra le aspettative americane e le ambizioni strategiche russe. Finché questo divario non sarà colmato, il percorso verso la fine del conflitto continuerà a restare complesso ed incerto.