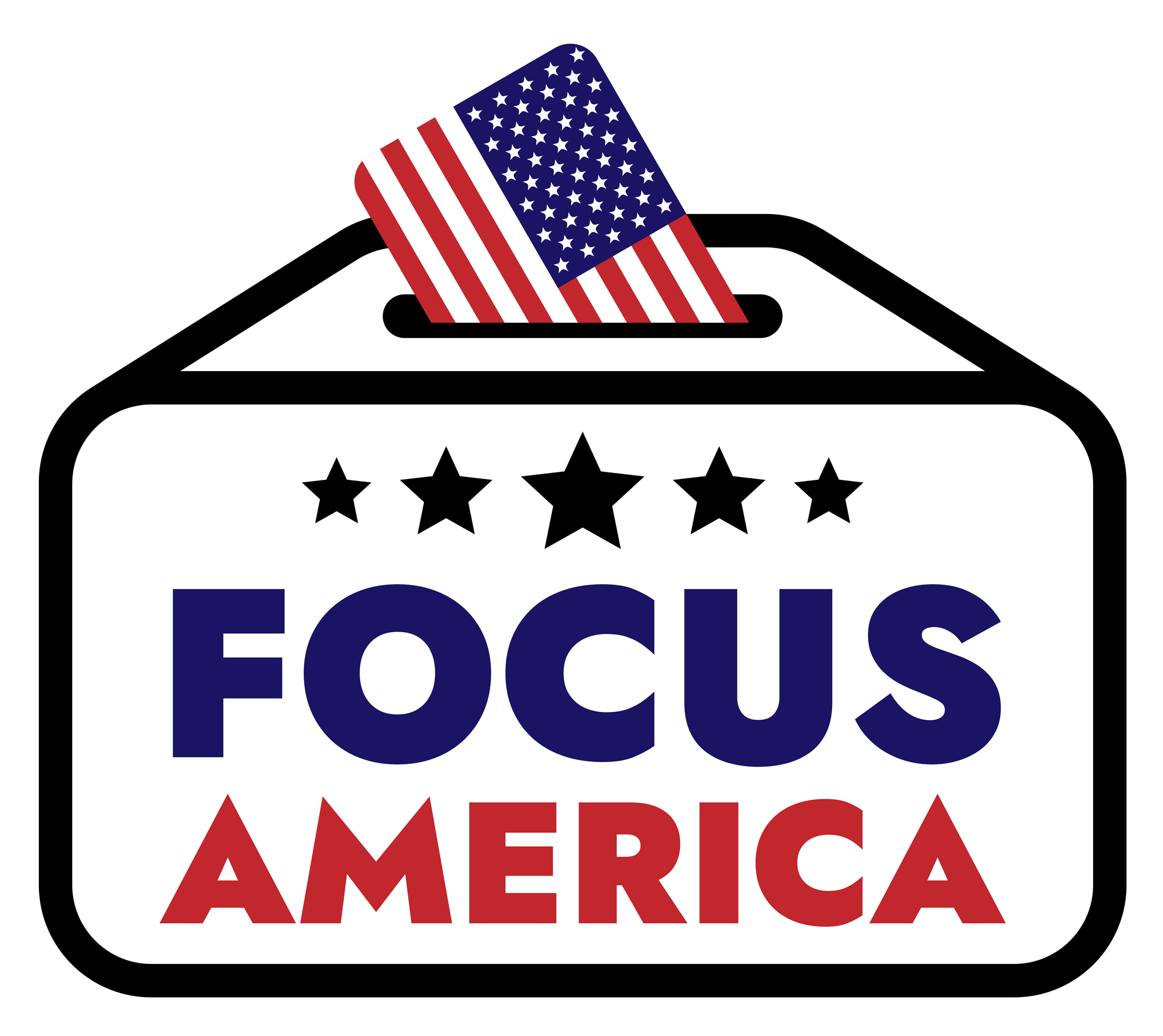Come funziona il sistema giudiziario degli Stati Uniti
Un sistema a due piramidi: una per la giustizia federale e una per quella statale. Operano in parallelo, ciascuna con competenze proprie, ma condividono una struttura a tre livelli.

Attentato, ex presidente sotto accusa, serial killer a processo: le notizie giudiziarie che arrivano dagli Stati Uniti sembrano sempre uscite da un film. Ma per capirle davvero — al di là del titolo sensazionale — bisogna sapere dove si svolge la scena. Negli Stati Uniti, ogni caso si muove dentro una doppia architettura giudiziaria: quella statale e quella federale. Conoscerne le regole è l’unico modo per leggere con lucidità le vicende legali che spesso anticipano, o decidono, le grandi svolte politiche e sociali del Paese.
Il sistema giudiziario degli Stati Uniti può essere immaginato come due piramidi affiancate: una per la giustizia federale, l’altra per quella statale. Operano in parallelo, ciascuna con competenze proprie, ma condividono una struttura a tre livelli: tribunali di primo grado alla base, corti d’appello al centro e la Corte Suprema al vertice.
Per orientarsi in questo doppio sistema, bisogna prima capire il concetto di giurisdizione — cioè l’autorità di un tribunale di pronunciarsi su un caso. Questa dipende sia dal territorio sia dalla natura della controversia: se riguarda una legge statale o federale.
Perché una causa approdi in un tribunale federale, deve coinvolgere una violazione della Costituzione o di una legge federale. Un esempio: un traffico di droga che parte dal Texas e arriva a New York. Attraversando i confini statali e infrangendo leggi federali sul narcotraffico, rientra chiaramente nella sfera federale. Lo stesso vale per un’aggressione avvenuta in un ufficio postale o in un parco nazionale: pur trovandosi fisicamente in uno stato, questi luoghi sono sotto giurisdizione del governo federale.
I tribunali statali, invece, hanno una giurisdizione generale: possono giudicare quasi ogni tipo di causa basata sul diritto statale. Qui si trattano i casi della vita quotidiana: divorzi, omicidi, cause per diffamazione, sfratti, multe per eccesso di velocità.
In entrambi i sistemi, i procedimenti seguono di base lo stesso percorso gerarchico. Se una delle parti contesta il verdetto, può appellarsi a un livello superiore, fino a raggiungere, in casi eccezionali, la Corte Suprema.
La corte federale
La differenza fondamentale tra tribunali federali e statali negli Stati Uniti non è nel modo in cui funzionano, ma nei casi che possono trattare. I tribunali federali hanno giurisdizione limitata: possono occuparsi solo delle controversie espressamente previste dalla Costituzione o dalle leggi federali, come le dispute tra Stati, le cause civili tra cittadini di Stati diversi che coinvolgono somme consistenti, i reati federali o le violazioni delle leggi fiscali e sull’immigrazione.
Il primo livello è costituito dai tribunali distrettuali federali: attualmente ce ne sono 94 attivi in tutto il Paese. Qui si svolgono i processi in primo grado per le cause che rientrano nella giurisdizione federale. Se una delle parti perde e intende contestare la sentenza, può fare ricorso al livello superiore: la Corte d’appello degli Stati Uniti.
Queste corti d’appello sono organizzate in 12 circoscrizioni, chiamate circuits. Ciascuna copre una regione geografica e ha sede in una città diversa. La Quinta Circoscrizione, ad esempio, comprende Texas, Louisiana e Mississippi, con sede a New Orleans. È lì che vengono esaminati i ricorsi provenienti dai tribunali distrettuali di questi Stati.
I giudici federali, inclusi quelli della Corte Suprema, non sono eletti: vengono nominati dal Presidente e confermati dal Senato, con incarico a vita.
Al vertice del sistema si trova la Corte Suprema degli Stati Uniti. A differenza delle corti d’appello, non è obbligata ad accettare i casi: ogni anno riceve oltre 7.000 richieste, ma ne accoglie solo circa 80. Perché un caso venga preso in esame, è necessario il voto favorevole di almeno quattro dei nove giudici. In genere, la Corte interviene quando esistono conflitti tra diverse corti d’appello o quando è coinvolta una questione costituzionale di interesse nazionale.
Come ultima istanza, la Corte Suprema può decidere su casi provenienti dai tribunali federali oppure, in alcuni casi, da quelli statali, se la questione riguarda un principio di diritto federale. Le sue decisioni sono definitive e possono avere conseguenze ben oltre l’aula in cui vengono pronunciate.
La corte statale
Il sistema giudiziario di ciascuno Stato americano ricalca, in larga parte, quello federale. Anche qui troviamo una struttura a tre livelli: tribunali di primo grado, corti d’appello statali e, al vertice, una Corte Suprema statale.
A differenza di quelli federali, i giudici statali vengono selezionati con criteri diversi, che variano da Stato a Stato: alcuni sono nominati dal governatore, altri dal parlamento statale, molti vengono eletti direttamente dai cittadini, a intervalli regolari.
La distinzione più significativa riguarda la giurisdizione. In sostanza, se non c’è una legge federale coinvolta o una competenza riservata, il caso resta nel sistema statale. È in queste corti, più che in quelle federali, che si misura il contatto diretto e quotidiano tra cittadini e giustizia.
Le differenze con il sistema italiano
Le divergenze tra il sistema giudiziario italiano e quello statunitense affondano le radici in due modelli giuridici opposti. L’Italia si fonda sul diritto codificato: norme scritte, raccolte in testi come il Codice Civile o il Codice Penale, che i giudici applicano nelle sentenze.
Negli Stati Uniti, al contrario, domina la common law, in cui le decisioni giudiziarie — soprattutto quelle dei tribunali superiori — costituiscono esse stesse fonte di diritto. Il precedente vincolante è la regola: ciò che un giudice stabilisce oggi può determinare l’esito di casi simili domani. La giurisprudenza, più che un archivio, è uno strumento attivo di creazione normativa.
Anche il processo assume forme diverse. In Italia, il giudice ha un ruolo attivo nell’accertamento dei fatti: può disporre prove, interrogare testimoni e collabora con il pubblico ministero nella fase preliminare. Negli Stati Uniti, invece, il processo è strutturato come uno scontro tra due parti contrapposte: accusa e difesa raccolgono prove, costruiscono le proprie versioni e interrogano i testimoni. Il giudice fa da arbitro, garantendo che le regole vengano rispettate, ma non prende parte all’indagine.
Una delle differenze più note riguarda la giuria popolare, presente in gran parte dei processi penali americani (e in alcuni civili). Dodici cittadini, estratti a sorte da registri pubblici come quello elettorale, decidono sui fatti del caso. Prima di entrare in aula, vengono sottoposti a un esame da parte di giudice e avvocati — per escludere pregiudizi o conflitti d’interesse. La partecipazione è un dovere civico e ignorare una convocazione può portare a sanzioni.
Il sistema americano è noto per la sua velocità. La maggior parte dei procedimenti penali si chiude prima del processo con un patteggiamento: l’imputato si dichiara colpevole in cambio di una pena ridotta. Oppure, nelle cause civili è frequente il settlement, un accordo economico tra le parti. Ma quando un processo arriva davvero in aula — soprattutto se c’è una giuria — può durare mesi.
La forma, nel processo americano, è sostanza. Le regole su prove, obiezioni, interrogatori sono rigide. Un errore procedurale può bastare a escludere una prova decisiva. Tutto si svolge in pubblico, sotto gli occhi della corte: ogni testimone parla in aula, ogni passaggio è registrato.
E poi c’è la questione dei costi. Difendersi in un processo americano può essere estremamente oneroso. Gli avvocati migliori hanno tariffe altissime, e chi può permettersi team legali privati, investigatori e periti parte avvantaggiato. Nei casi gravi — omicidio, frode, corruzione — una difesa completa può superare i 100.000 dollari. Per chi non può permettersela, esistono i public defenders, avvocati d’ufficio garantiti dallo Stato: alcuni sono eccellenti, altri sopraffatti dal carico di lavoro.
Casi esemplari: come si trasferisce il potere decisionale
Negli Stati Uniti, un caso può rimanere all’interno del sistema giudiziario statale oppure passare a quello federale. Tutto dipende dal tipo di reato, dalle leggi coinvolte e da chi ha giurisdizione sul tema.
Nel Massachusetts, come in ogni altro Stato, i tribunali statali si occupano della maggior parte delle controversie: omicidi, dispute tra inquilini e proprietari, casi civili e penali che rientrano nelle leggi locali.
Ma ci sono eccezioni. L’attentato alla maratona di Boston del 2013 ne è un esempio. Anche se è avvenuto all’interno dello Stato e gli imputati erano residenti del Massachusetts, il caso è stato giudicato in un tribunale federale. Perché? Le accuse riguardavano reati di terrorismo e crimini contro il governo degli Stati Uniti, previsti dalla legge federale.
Un esempio centrale del potere della Corte Suprema degli Stati Uniti è il celebre Roe v. Wade del 1973. Il caso nacque in Texas, quando Norma McCorvey (sotto lo pseudonimo “Jane Roe”) contestò la legge statale che vietava l’aborto salvo nei casi di pericolo per la vita della madre. Roe intentò una causa contro Henry Wade, procuratore distrettuale della contea di Dallas. All’epoca, la legge del Texas vietava quasi ogni forma di aborto, salvo nei casi in cui la vita della madre fosse in pericolo. Roe sostenne che quella legge violava il diritto alla privacy garantito dalla Costituzione degli Stati Uniti.
Il caso fu inizialmente esaminato da un tribunale distrettuale federale, che giudicò la legge texana incostituzionale, ma non bloccò formalmente la sua applicazione. Entrambe le parti fecero ricorso: Roe chiedeva un’ingiunzione più forte, mentre il Texas voleva difendere la validità della propria legge sull’aborto.
La questione arrivò così alla Corte Suprema, che accettò di esaminarla. Con una decisione di 7 a 2, i giudici stabilirono che il diritto all’aborto rientrava nella tutela della privacy prevista dal Quattordicesimo Emendamento. La legge del Texas fu quindi annullata, e la sentenza estese questo principio a livello federale, limitando la possibilità per tutti gli altri Stati di vietare l’aborto.
Ma il sistema giudiziario americano è in costante evoluzione e riflette la società che cambia: i precedenti possono resistere, adattarsi o cadere.
Nel 2018, il Mississippi ha approvato una legge ha approvato una legge che vietava l’aborto oltre la quindicesima settimana di gravidanza, in netto contrasto con quanto stabilito da Roe v. Wade e Planned Parenthood v. Casey. La Jackson Women’s Health Organization, unica clinica autorizzata a praticare aborti nello Stato, ha impugnato la legge davanti a un tribunale distrettuale federale, sostenendo che fosse incostituzionale.
Il tribunale ha dato ragione alla clinica, e la decisione è stata confermata in appello dalla Corte del Quinto Circuito, che ha ribadito l’incompatibilità della legge con i precedenti federali. In risposta, il Mississippi ha presentato ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, chiedendo non solo di convalidare la legge statale, ma anche di rivedere il principio costituzionale stabilito da Roe v. Wade.
Nel giugno 2022, con la sentenza nel caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, la Corte Suprema ha accolto la richiesta: ha annullato il precedente Roe, concludendo che la Costituzione non garantisce un diritto federale all’aborto e restituendo la regolamentazione ai singoli Stati.
La decisione non ha solo ribaltato un precedente: ha ridistribuito il potere, riacceso il conflitto e spostato la posta in gioco a livello locale. Ma in un sistema in cui la giustizia si muove con la società, nulla resta fermo a lungo.