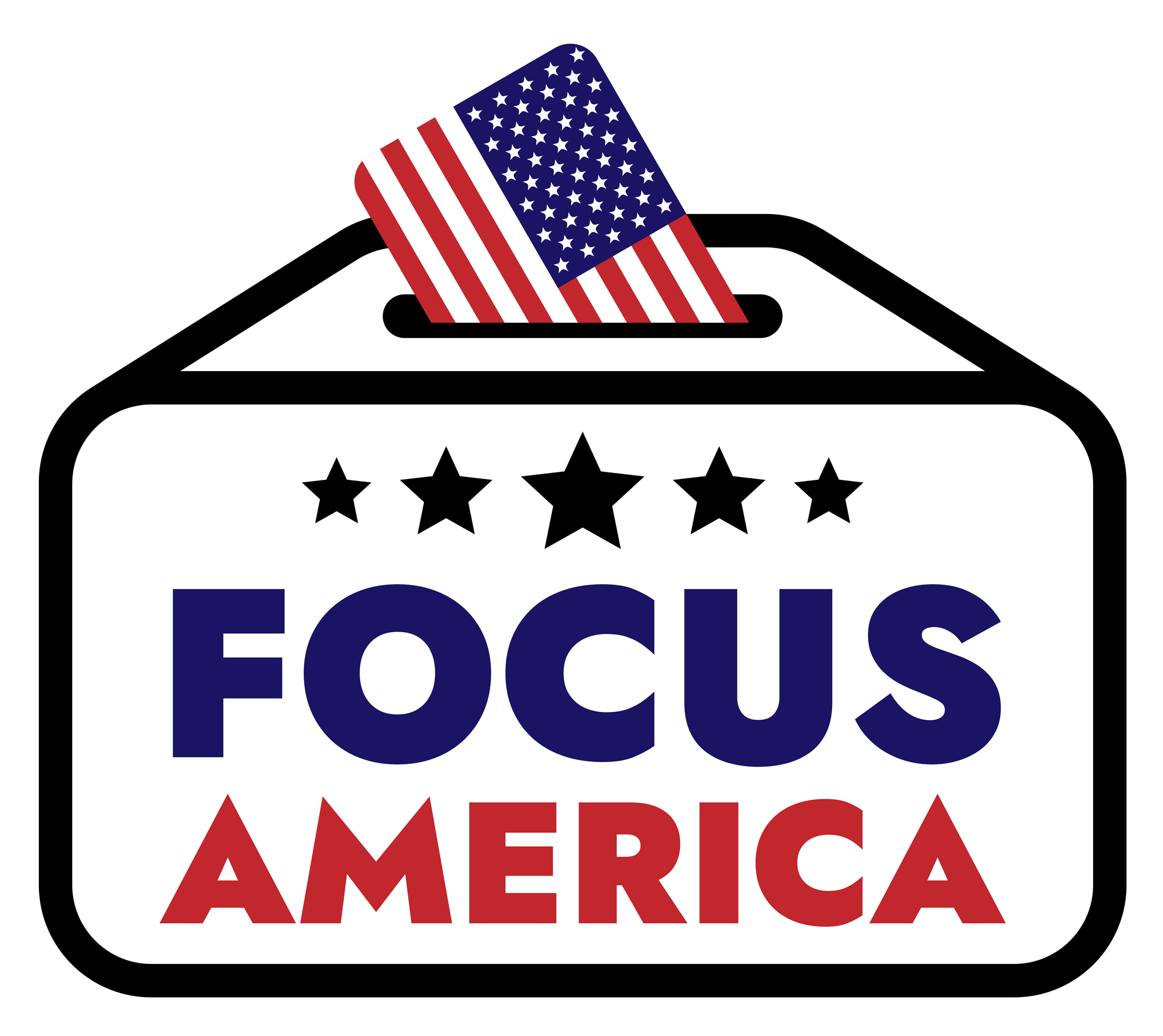Berkeley collabora con l’amministrazione Trump su presunti casi di antisemitismo
Il celebre campus californiano ha trasmesso a Washington i nomi di 160 studenti e docenti, tra cui la filosofa Judith Butler. La decisione ha suscitato proteste nel mondo accademico e richiami alla storia del Free Speech Movement.

Il 4 settembre 160 studenti e docenti dell’Università di Berkeley hanno ricevuto una comunicazione inattesa: i loro nomi erano stati inseriti in una lista trasmessa all’amministrazione Trump. L’elenco rientra in un’indagine federale su presunti episodi di antisemitismo nel campus. Nessuno degli interessati conosce però le accuse precise a proprio carico.
L’unico nome reso pubblico è quello della filosofa Judith Butler, docente a Berkeley da quasi trent’anni. Butler ha risposto con una lettera aperta, pubblicata da The Nation, Libération e La Stampa, in cui ha paragonato la vicenda al processo kafkiano: persone accusate di un crimine ignoto, senza possibilità di difesa.
Il caso si inserisce nell’offensiva lanciata dal presidente contro le università, ufficialmente in nome della lotta all’antisemitismo. La strategia prevede l’apertura di “indagini”, il blocco di fondi federali e l’imposizione di accordi finanziari. Columbia, minacciata di perdere 1,3 miliardi di dollari, ha accettato un patteggiamento da 221 milioni. Harvard, oggetto di dodici indagini, ha portato la questione in tribunale, trattando parallelamente un’intesa da 500 milioni.
Berkeley è l’unico tra i nove campus dell’Università della California ad aver dichiarato la propria collaborazione. Una scelta criticata da Todd Wolfson, presidente dell’Associazione americana dei professori universitari, che ha parlato di “mancanza di coraggio” e di “violazione flagrante della riservatezza del corpo docente”. L’associazione ha presentato denuncia contro il governo, come già nel caso di Harvard.
Il significato simbolico della decisione è forte. Simon Ridley, storico specializzato sull’ateneo, ricorda che l’ultima collaborazione di questo tipo risale al maccartismo, quando l’università aveva denunciato docenti sospettati di “antiamericanismo”. Negli anni Sessanta Berkeley era stata culla del Free Speech Movement, che rivendicava il diritto alla libertà di espressione degli studenti e divenne modello per i movimenti giovanili successivi.
Il 13 settembre alcuni veterani del movimento hanno scritto al presidente del campus: “Avete il dovere di dire NO, come facemmo noi sessantun anni fa: se vengono a prendere qualcuno, dovranno prendere tutti”.
Anche il sociologo Eric Fassin ha denunciato la svolta, sottolineando che “vista la sua storia, ci si poteva aspettare che Berkeley resistesse”. Ha promosso una lettera, pubblicata da Libération e firmata da oltre 600 accademici di tutto il mondo, in cui si ricorda che le università hanno obblighi non solo verso lo Stato ma anche verso i propri docenti e studenti, titolari di diritti accademici e politici.
Un’altra presa di posizione è arrivata da circa 200 professori ebrei dell’Università della California, che hanno chiesto ai regenti di non scendere a patti con Washington: “Nessuna concessione, nessun compromesso, nessuna capitolazione. Non in nostro nome”.
La decisione di Berkeley segna dunque un passaggio di rilievo nella tensione tra mondo accademico e amministrazione federale. Per molti osservatori, rappresenta non solo una questione legale e politica, ma anche un punto di svolta simbolico nella memoria di un campus che aveva fatto della libertà di espressione la propria bandiera.